Ancora su figli maggiorenni e diritto al mantenimento
di Gianfranco Gilardi
Sommario:1. L’indirizzo della Corte di cassazione e l’ordinanza 14 agosto 2020, n. 17183 - 2. Funzioni di “nomofilachia” e critiche all’ordinanza - 3. Il sistema positivo e la lettura dell’art. 337-septies c.c. - 4. Considerazioni conclusive.
1. L’indirizzo della Corte di cassazione e l’ordinanza 14 agosto 2020, n. 17183
Con una sorprendente decisione, emessa in pieno periodo feriale, la Prima sezione della Corte di cassazione ha compiuto una brusca sterzata rispetto al pluridecennale orientamento (peraltro confermato in una decisione di appena qualche mese anteriore rispetto a quella che adesso si annota: Cass., n. 7555/2020, ord., in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti) secondo cui l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio a norma degli artt. 147 e 148 c.c. (v., oggi, gli artt. 315-bis c.c., introdotto dalla legge n. 219/2012 e 316-bis c.c. introdotto dal d.lgs. n.154/2013) non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr., ex multis, Cass. n. 32529/2018, ord.; n. 5088/2018, ord.; n. 12952 /2016; n. 18076/2014; n. 1773/2012; n. 19589/2011; n. 1830/2011; n. 16612/2010; n. 407//2007; n. 22491/2006 ; n. 12477/2004 n. 1353/1999; n. 24498/2006; n. 4765/2002; n. 9109/1999; n. 7195/1997; n. 496/1996; n. 12952/1993); ed il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio (Cass. n. 13184/2011).
Riassuntivamente, secondo il precedente e consolidato orientamento l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato da parte del figlio; ed il corrispondente accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione: con la conseguenza di doversi escludere, in via generale, che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio il quale rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 18076/2014 e n. 4765/2002, citate)[1].
Tale indirizzo si era mantenuto costante così nel vigore dell’art. 155-quinquies c.c., introdotto con la riforma di cui alla legge n. 54/2006, come dopo le modifiche al c.c. apportate dal d.lgs. n. 154/2013, modifiche che, peraltro, hanno lasciato immutato il contenuto dell’art. 155-quinquies anteriormente vigente. E nell’ambito di tale orientamento si era precisato di volta in volta che la prova della mancanza di indipendenza economica del figlio divenuto maggiorenne deve essere fondata su un accertamento di fatto avente riguardo “all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (così, ad es. Cass. n. 12952 /2016, n. 19589/2011 e n. 15756/2006, citate); che l'onere della prova incombente sul genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento può essere assolto anche in via presuntiva alla stregua di circostanze di fatto da cui desumere l'estinzione dell'obbligo, “con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole….possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe…..in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. n. 18076/2014, citata ed, ivi, i precedenti richiamati); che tra le circostanze presuntive possono essere annoverate l'avvenuto svolgimento, con rapporto di collaborazione continuativa, di un’attività di lavoro, anche se venuta successivamente a cessare (Cass. n. 24498/2006, n. 12477/2004 e n. 7195/1997, citate); la sopravvenuta adozione del figlio da parte del nuovo marito della madre, ove ne derivi il suo stabile inserimento nel contesto familiare così venutosi a creare (n. 7555/2020, cit.), mentre il raggiungimento dell'indipendenza economica non è dimostrato né dalla mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista (n. 407//2007, citata), né dal conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di 800 euro mensili: n. 2171/2012, citata) o di un titolo di studio universitario, né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (n. 1830/2011, citata).
All’improvviso revirement dell’ordinanza, riassumibile nella conclusione che con la maggiore età cessa il diritto al mantenimento del figlio salvo che non sia provata dal richiedente (il coniuge o lo stesso figlio divenuto maggiorenne) la condizione di non autosufficienza economica per cause al figlio non imputabili, la Corte è pervenuta sulla base delle seguenti considerazioni:
- la previsione dell’art. 337-septies c.c. introdotta con l’art 55 del d.lgs. n. 154/2013 che ha riprodotto integralmente il contenuto dell’art.155-quinquies c.c. subordina il diritto all’attribuzione dell’assegno di mantenimento al figlio divenuto maggiorenne - oltre che alla circostanza dell’essere quest’ultimo economicamente non indipendente - ad una valutazione discrezionale (il giudice “può”) delle circostanze relative al caso concreto (par.1 dell’ordinanza). In base a tale disposizione, con il raggiungimento della maggiore età il diritto al mantenimento non potrebbe più correlarsi ad un obbligo dei genitori discendente “direttamente ed automaticamente” dalla mancanza di indipendenza economica del figlio, ma costituirebbe l’effetto di una dichiarazione giudiziale attributiva di un diritto “prima di quel momento inesistente”, l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni essendo collegata dalla legge “all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età”, salva la prova “che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica” (par.4.4);
- nella giurisprudenza della Cassazione sono ormai acquisiti i principi relativi alla "funzione educativa del mantenimento" ed all’"autoresponsabilità", da coniugare tenendo conto correlativamente dei “doveri gravanti sui figli adulti: il riconoscimento in favore dei figli conviventi e “sedicenti non autonomi” di un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa più favorevole del mantenimento, mentre per gli altri varrebbe unicamente il diritto agli alimenti[2] (par. da 4.2 a 4.2.2.);
- le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno", a volte in capo allo stesso genitore, hanno indotto la giurisprudenza a sottolineare la rilevanza connessa all'avanzare dell'età, l'obbligo di mantenimento non potendo “essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto” e l'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative potendo “costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli". La funzione educativa del mantenimento è invero “nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società"; e si renderebbe dunque “esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore”. Tenuto conto anche dell’indirizzo interpretativo che si è venuto affermando con riguardo al diritto all'assegnazione della casa familiare, ciò confermerebbe che - ogniqualvolta vengono in rilievo i concetti del dovere e dell’autoresponsabilità - “ e non solo quelli del "diritto ad ogni possibile diritto" - anche il nostro ordinamento procede “di pari passo con l'evoluzione della società civile, pur corroborando tali principi con l'applicazione razionale e perdurante del principio di solidarietà ex art. 2 Cost.” (par.4.2.3 dell’ordinanza, che nel par. successivo si produce in un’ampia esemplificazione della casistica in cui la cassazione nelle materie più diverse - come ad esempio nei contratti di investimento finanziario, nella compravendita, nella trascrizione, in materia di risarcimento del danno con riguardo all’art. 1227 c.c., in campo processuale - ha fatto applicazione del principio dell’autoresponsabilità “anche in presenza di un diritto che chieda di essere affermato, ed, anzi, proprio per rendere ragionevole e "sostenibile" qualsiasi diritto”, la pienezza della scelta esistenziale personale dovendo sempre “ fare i conti nel bilanciamento con le libertà e diritti altrui di pari dignità”;
- tale conclusione sarebbe coerente con gli artt. 1, 4 e 30 Cost. e costituirebbe applicazione del “principio dell’abuso del diritto” o - più precisamente - “della buona fede oggettiva”, il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non potendo “sorgere già "abusivo" o "di mala fede". Poiché la capacità lavorativa si acquista con la maggiore età, e cioè in quell’età in cui, secondo l'id quod plerumque accidit, “si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita” e la legge presuppone raggiunta un'autonomia che giustifica l’attribuzione della “capacità di agire (e di voto)”, al figlio maggiorenne - in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall’altro - dovrebbe essere negato il diritto al mantenimento, salva la prova di circostanze tali da giustificare il permanere dell’obbligo in capo ai genitori (par.4.4 e 4.5.1);
- tra le evenienze determinanti il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si porrebbero: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione diligente di studi ultraliceali, da cui poter desumere “l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini” da ritenere “ancora legittimamente in corso di svolgimento” se vengano dimostrati “effettivo impegno ed adeguati risultati” quali emergenti “dalla tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso”; c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi che il figlio abbia reputato a sé idoneo; d) il mancato reperimento - nonostante tutti i possibili tentativi di ricerca cui il figlio si sia ”razionalmente ed attivamente adoperato” - di un qualsiasi lavoro, confacente o no alla propria specifica preparazione professionale” (par. da 4.5.2 a 4.5.4).
Corollario della tesi secondo cui con la maggiore età cessa il diritto al mantenimento - salva l’esistenza di circostanze tali da giustificare la permanenza del relativo obbligo in capo ai genitori - è che l'onere della prova della ricorrenza di tale condizione sia a carico del richiedente: una conclusione che, tra l’altro, sarebbe si porrebbe in armonia “con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (par. 4.6.).
2. Funzioni di “nomofilachia” e critiche all’ordinanza
L’ordinanza presta il fianco a diverse critiche[3], alcune delle quali sono state già sollevate in questa stessa Rivista[4].
Essa appare innanzi tutto criticabile sotto il profilo del metodo, l’improvvisa sterzata rispetto al precedente e consolidato orientamento essendo stata affidata non ad una sentenza, ma alla forma dell’ordinanza, in contrasto con la funzione di nomofilachia della cassazione e con la stessa formulazione delle norme positive.
Com’è noto, alla funzione di nomofilachia della Cassazione il legislatore è venuto attribuendo rilievo prioritario e crescente a partire dalle modifiche al codice di rito introdotte con il d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40[5] in attuazione della legge delega 14 maggio 2005 n. 35, proseguendo poi con la legge 18 giugno 2009 n. 69[6]; con la legge 7 agosto 2012 n. 134 di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83[7] e con il decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 che, introducendo come regola la trattazione in camera di consiglio, conclusa con ordinanza, e come eccezione l’udienza pubblica, conclusa con sentenza da adottare nei (soli) casi in cui “sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale (la Corte) deve pronunciare” (art. 375, secondo comma)[8] ha dato origine a quella che è stata definita la sostanziale “cameralizzazione” del giudizio civile di cassazione”[9]. Il percorso legislativo si è poi concluso con la legge 23 giugno 2017, n. 103 che ha esteso al giudizio penale la regola già vigente per quello civile, secondo cui la sezione semplice ha l’obbligo di rimessione alle sezioni unite ogniqualvolta ritenga di non condividere il principio di diritto da queste enunciato (nuovo comma 1-bis dell’articolo 618 cpp).
Anche l’appropriata applicazione delle norme processuali costituisce un aspetto della “certezza del diritto” cui deve contribuire la funzione di nomofilachia, il processo essendo il luogo in cui più che mai deve essere garantita l’esigenza di certezza e stabilità delle regole del gioco[10]. E se è vero che la forma prescelta nel caso in esame (ordinanza anziché sentenza) non ha alcuna conseguenza rispetto alla fattispecie decisa, ciò non toglie che il provvedimento si ponga pur sempre come precedente, con potenziali effetti futuri anche sotto il profilo dell’incremento della litigiosità e del contenzioso[11].
Ora non sembra potersi affermare che, a fronte di un discostamento di tale rilevanza, l’ordinanza (forma propria dei provvedimenti che hanno caratterizzato numerosi precedenti allineati sull’orientamento consolidato) fosse lo strumento più adatto; né potrebbe sostenersi che si fosse in presenza di un caso di manifesta infondatezza del ricorso dal punto di vista del revirement interpretativo accolto nell’ordinanza,
Ugualmente sorprendente, non solo nel metodo, ma anche nel merito è che ai copiosi richiami ed all’ampio excursus sui precedenti giurisprudenziali contenuti nei paragrafi da 4.2.1.1 a 4,4. dell’ordinanza (in cui sono ribaditi principi alla stregua dei quali sarebbe stato probabilmente possibile - e questa volta proprio con la forma dell’ordinanza - pervenire al rigetto del ricorso o, prima ancora, alla declaratoria della sua inammissibilità senza dover aggiungere altri argomenti[12]) faccia seguito - quasi ne costituisse un corollario o uno sviluppo - quella che in realtà costituisce una repentina virata rispetto all’indirizzo espresso in tali precedenti, a tutti i quali è sotteso (o nei quali a volte è anche espressamente richiamato) quel concetto di “autoresponsabilità” cui l’ordinanza sembra affidare principalmente le ragioni della svolta: laddove l’”autoresponsabilità” altro non esprime che quel dovere di attivazione cui nelle precedenti decisioni si era fatto costante riferimento, senza con questo ricavarne la conseguenza che al raggiungimento della maggiore età venga a cessare, da un giorno all’atro, l’obbligo di mantenimento in capo al genitore con corrispondente estinzione del relativo diritto in capo al figlio.
E proprio perché a tale conclusione (peraltro formulata, almeno sul piano terminologico, con una ricorrente scambio del concetto di attribuzione ex art. 337-septies c.c. di un diritto prima inesistente, con quello di estinzione del diritto a causa della mancata prova in ordine all’incolpevole condizione di non indipendenza economica dopo il raggiungimento della maggiore età[13]) l’ordinanza è pervenuta con affermazioni implicanti una netta cesura rispetto a quanto anteriormente e costantemente affermato dalla medesima sezione della Corte, nel caso deciso veniva a profilarsi - in considerazione appunto di tale cesura – la particolare rilevanza della questione di diritto che avrebbe imposto la pronuncia con sentenza.
Anni di elaborazione e fiumi di inchiostro intorno al concetto di nomofilachia sembrano dunque dispersi nell’enunciazione di un principio di diritto che nel contesto dell’ordinanza affiora quasi come un obiter dictum; e si perde ogni significato del valore del precedente che - pur non avendo nel nostro ordinamento il carattere vincolante di una “regola juris” - “quando si traduca in un orientamento consolidato della Suprema corte, non ha soltanto una valenza persuasiva ma assume anche una più pregnante rilevanza giuridica”[14]; e “se non giunge mai ad intaccare il principio della soggezione del giudice solo alla legge”, restando pur sempre garantiti “il dissenso e l’evoluzione della giurisprudenza, la correzione, il ripensamento o l’innovazione dei suoi orientamenti”, si colloca in un quadro normativo in cui dissenso e cambiamento “devono essere motivati e fondati su elementi ..così convincenti da far prevalere le ragioni del cambiamento rispetto alla tutela dell’affidamento ed al diritto dei cittadini ad essere uguali dinanzi all’interpretazione della legge, ad avere un uguale trattamento giurisdizionale”[15].
3. Il sistema positivo e la lettura dell’art. 337-septies c.c.
Come s’è detto, la conclusione accolta nell’ordinanza in commento si fonda - quanto alle norme positive – sulla considerazione che il dovere di mantenimento dei figli avrebbe assunto connotati nuovi sin dalla riforma di cui alla legge n.54/2006, che mediante l'art. 155-quinquies c.c. (poi riprodotto nell’art. 337-septies c.c. nel corpo delle innovazioni di cui al d.lgs. n. 154/201) ha dettato una disposizione ad hoc in favore di figli maggiorenni. Fin da allora, pertanto, sussisterebbero modalità diverse per l'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio, a seconda che questi sia un minorenne (valendo in tal caso la disciplina dettata dagli artt. 147 - richiamato dall’art. 48, 2° comma, l. 4 maggio 1983, n. 184 - e 315-bis c.c) ovvero un maggiorenne economicamente non indipendente, per il quale la regolamentazione andrebbe rinvenuta nell’art. 337-septies c.c.in base al quale l’obbligo di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne “non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore”, ma sarebbe rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto. Affinché tale obbligo possa configurarsi, non sarebbe pertanto sufficiente – “pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice” – la mancanza di indipendenza economica del figlio maggiorenne, ma occorrerebbe una statuizione del giudice attributiva “del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente” (cfr. altresì il par. 4.5.4., in cui vengono indicate le evenienze che «comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne»).
Questa lettura “innovativa” dell’art. 337-septies (già art. 155-quinquies) c.c. trascura di considerare che, nel sistema normativo, i doveri nei confronti dei figli scaturiscono dalla filiazione e prescindono sia dal rilievo che con il conseguimento della maggiore età il figlio acquista la piena capacità di agire (ivi compresa la possibilità di esercitare il diritto di voto, che l’ordinanza ha cura di richiamare senza che se ne intraveda l’utilità rispetto alla questione decisa), sia dalla circostanza che da quel momento vengono meno i poteri disciplinari e rappresentativi in capo ai genitori; lo stesso art. 337-septies c.c. sta anzi a dimostrare che per il legislatore un obbligo di mantenimento può sussistere anche quando la funzione educativa (ma anche quella di assistenza e di istruzione) “debba confrontarsi con il raggiungimento della maggiore età del figlio”, né la norma conosce distinzione alcuna, sotto il profilo dell’età dei figli, con riguardo alla “speculare materia dell’assegnazione della casa coniugale”[16].
Come è stato puntualmente osservato nelle note critiche degli autori più sopra ricordati, il dovere di mantenimento trova il proprio titolo nell’ art. 30 della Cost. e negli artt. 147 e 315 e segg. c.c che, nell’imporre ai genitori l’obbligo di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”, non contengono alcuna distinzione con riguardo all’età dei figli, in tal modo configurando un regime unitario salve le eccezioni espressamente previste, come quella relativa alla norma dell’art. 315-bis, terzo comma c.c. applicabile ai soli figli minorenni. L’art. 337-septies (come già, prima, l’art. 155-quinquies) c.c., inserendosi nel contesto delle disposizioni di cui agli artt. 315 e segg. c.c., non ha il significato di prevedere la reviviscenza - subordinata alla prova della condizione di non autosufficienza economica - di un diritto venuto ad estinguersi per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma, più semplicemente, quello di escludere che il raggiungimento della maggiore età sia incompatibile con il diritto al mantenimento, tanto che il giudice (nonostante il figlio sia diventato maggiorenne e sempre che, naturalmente, un assegno di mantenimento non sia già stato disposto in precedenza) può disporlo, ed favore dello stesso figlio direttamente, una volta valutate le circostanze del caso concreto: tra le quali deve essere annoverata, naturalmente, anche la situazione concreta dei genitori, fermo altresì restando - ciò di cui mai si è dubitato nella giurisprudenza, senza necessità di ricorrere alla categoria dell’”abuso del diritto” elaborata per altre situazioni[17] - che non può esservi spazio per “rendite parassitarie, escluse dal principio di responsabilità che investe qualunque soggetto adulto e capace” [18]. In altri termini, il campo di operatività dell’art. 337-septies c.c. è limitato alle modalità di esercizio dei diritti dei figli maggiorenni (economicamente non autosufficienti) e di adempimento dei doveri genitoriali in caso di separazione, divorzio, cessazione della convivenza; ed ha la sola funzione di specificare che l’obbligo di mantenimento può essere assolto mediante il versamento di un assegno periodico da corrispondere direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice [19].
4. Considerazioni conclusive
Nell’affermazione secondo cui il raggiungimento dalla maggiore età comporta l’estinzione del diritto al mantenimento salvo prova della mancanza di autonomia economica del figlio divenuto maggiorenne, sembra in qualche modo disperdersi il senso dell’evoluzione che, sotto la spinta della dottrina, della giurisprudenza e della cultura giuridica e nella cornice delle più ampie sollecitazioni provenienti dalla carta costituzionale e dalle convenzioni internazionali, è venuta progressivamente adeguando il diritto di famiglia alle vecchie/nuove istanze ed ai nuovi bisogni di giustizia maturati all’interno della società: un’evoluzione di cui, ad esito di un processo ancora oggi lontano dall’essere compiuto, costituiscono tra le espressioni più significative la legge n. 219/2012 sull’equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi' ed il d.lgs. n. 154/2013 volto a completare il percorso di equiparazione ed introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, in un solco in cui sono venute emergendo la figura e la soggettività non solo del minore ma, più in generale, dei figli quali titolari di aspettative e di diritti e, in particolare, di quel diritto al futuro che la Costituzione riconosce e garantisce, non solo nelle norme specifiche contemplanti la famiglia, il dovere di istruzione, educazione e mantenimento dei figli, la maternità, l'infanzia e la gioventù, la scuola e l'insegnamento, ma nel tessuto intero del suo impianto in cui si esprime, appunto, l'impegno di costruzione del presente anche come garanzia di tutela del futuro, in un continuum in cui le generazioni che oggi si affacciano al mondo siano viste come beneficiarie e, insieme, come artefici del progetto per cui il desiderio di vivere una vita serena e dignitosa, il bisogno di essere liberi dalla paura, a cui tutti giustamente aspiriamo, ed a cui occorre dare risposte concrete, siano perseguiti per tutti in nome dei diritti che ogni uomo ed ogni donna acquistano per il fatto stesso della nascita.
Nel quadro di questa evoluzione, il d.lgs. n. 154/2013 ha sostituito “l’obsoleto istituto della potestà genitoriale con quello della responsabilità genitoriale” eliminando la limitazione temporale originariamente collegata nell'art. 316 c.c. al compimento della maggiore età dei figli o alla loro emancipazione: con la conseguenza che, nell’assetto normativo vigente, la cura cui il genitore è tenuto nei confronti del figlio prosegue oltre il raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento della indipendenza economica[20].
Se l’evoluzione legislativa cui si è fatto accenno fosse stata tenuta in maggiore considerazione, forse la Corte sarebbe stata più cauta nell’affermare che la maggiore età, “tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita," anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne” implica “l'insussistenza del diritto al mantenimento”; e, nel teorizzare l’estinzione del diritto (salvo reviviscenza per effetto di un provvedimento del giudice ex art. 337-septies c.c.), si sarebbe quanto meno preoccupata di dare una risposta al quesito su chi ricada, nel frattempo, il dovere di mantenimento di un figlio che - a dispetto del raggiungimento della maggiore età, nonostante che la Repubblica italiana sia “fondata sul lavoro” e benché con la maggiore età si acquisti per legge “piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro”[21] – si trovi nella condizione di non poter provvedere a se stesso. Forse la Corte si sarebbe prospettata l’evenienza che l’obbligato possa cessare - indipendentemente dalla propria condizione economica, e quindi anche quando la situazione patrimoniale gli permetterebbe tranquillamente di assolvere i il proprio obbligo[22] - la corresponsione di qualunque assegno al compimento del diciottesimo anno dì età del figlio, con l’effetto di trasferire su quest’ultimo o sull’altro genitore non soltanto l’onere della prova[23] ma, prima ancora, quello dell’iniziativa giudiziaria, anche solo per la conservazione della parte corrispondente al più ridotto importo alimentare che nell’ordinanza si riconosce comunque dovuta a prescindere dall’età[24]; e riflettendo sull’interpretazione accolta, non avrebbe mancato di porsi qualche dubbio in relazione al fatto che durante il tempo occorrente al conseguimento di una decisione giudiziaria, il figlio verrebbe a trovarsi privato dei mezzi necessari per fronteggiare esigenze che hanno bisogno di essere soddisfatte giorno per giorno e non in tempi differiti proprio negli anni più vicini, secondo quanto normalmente accade, al momento dei reali bisogni formativi[25], con inevitabili ricadute sul genitore convivente costretto a farsi interamente carico del suo mantenimento.
Prima ancora che il Covid 19 gettasse nell’angoscia l’intera umanità, la precarizzazione del mondo del lavoro costituiva già una piaga sociale che, non risparmiando i lavoratori adulti di entrambi i sessi, aveva investito soprattutto le fasce giovanili e, sovvertendo ciò che per alcuni decenni era stato il modello sociale europeo, aveva messo a nudo il volto di un mondo in cui alla perdita ed alla mancanza del lavoro facevano riscontro la povertà crescente e la perdita di senso individuale e collettivo. Termini come incertezza, rischio, disagio psicosociale, che connotavano ormai tanto il lavoro manuale e operaio, quanto il lavoro della conoscenza, costituivano aspetti di una dolorosa dimensione esistenziale.
Di fronte a ciò, affermazioni come quella che individua quale preciso dovere del figlio la ricerca dell'autosufficienza economica, ipotizzando che tale dovere sussista, sia ex ante,”sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative”, sia ex post, quando esso si atteggia quale dovere di ricercare “qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione”, in attesa “dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni” hanno quasi il sapore di un abbandono a se stesse delle nuove generazioni, somigliano ad una sorta di invito ad “arrangiarsi” che finisce per cancellare ogni spazio a quelle legittime aspirazioni ed a quelle attitudini personali che - mai pretermesse dai precedenti giurisprudenziali richiamati nell’ordinanza - costituiscono parte specifica ed integrante del diritto positivo e presupposto per la realizzazione di quel valore della dignità della persona in cui è racchiuso il senso più profondo della carta costituzionale.
Si è dunque in presenza di un provvedimento che, pur non sussistendone alcuna necessità ai fini della decisione, si è discostato da quei “parametri di riferimento” e da quei principi che la Corte, in più di vent’anni di giurisprudenza, era venuta elaborando “in coerenza al proprio compito di nomofilachia ex art. 65 ord. giud..…ai fini di uniformità, uguaglianza e più corretta interpretazione ed applicazione della norma” (così l’ordinanza in commento, par. 4.1), tutti riassumibili nella massima secondo cui non è la maggiore età, ma il conseguimento dell'indipendenza economica (o il colpevole mancato raggiungimento di essa) il fatto estintivo della obbligazione di mantenimento gravante sui genitori, un fatto che - come tutti quelli estintivi del credito - deve essere provato dal debitore; e tale discostamento è avvenuto, in forma quasi incidentale, senza alcuna conseguenzialità con quei parametri e quei principi che pure l’ordinanza aveva mostrato di condividere.
Ma, com’è stato osservato, fermo il diritto-dovere di ogni giudice (sia di merito, sia di legittimità) di sottoporre a critica gli orientamenti giurisprudenziali pregressi che non gli appaiano convincenti, l’esigenza – per quanto attiene alla Corte di cassazione – “di tener conto dei propri stessi precedenti si radica nella istituzionale funzione di assicurare l’unità del diritto oggettivo nazionale” e “nella conseguente necessità di garantire (almeno tendenzialmente) i valori di coerenza ed uguaglianza insiti nell’ordinamento”; ed è sempre necessario “saper bilanciare l’etica della convinzione con l’etica della responsabilità”, anche perché - egli osserva – “ogni decisione è certo un unicum, in rapporto alla specifica controversia che risolve, ma nel medesimo tempo è il tassello di un più ampio tessuto giurisprudenziale in cui deve potersi armonizzare”.
[1] Cfr., per l’indirizzo della Cassazione sul tema dell’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, G. Luccioli, Diario di una giudice. I miei cinquant’anni in magistratura, Forum 2016, pag. 77 e segg., che alla formazione di tale indirizzo come a quella di altri fondamentali ed innovativi orientamenti della Corte di cassazione ha dato un contributo decisivo.
[2] Così la motivazione dell’ordinanza, in cui vengono richiamati diversi precedenti tra cui quello secondo cui l'obbligo dei genitori - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - non può protrarsi “sine die”, trovando il suo limite logico e naturale nei casi in cui i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o siano stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad assicurare loro le normali esigenze di vita; quando abbiano conseguito la possibilità di ottenere un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne; quando comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, o ancora si siano inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune.
[3] Vedi, ad es. G. De Marzo, Figli maggiorenni e diritto al mantenimento. Le ragioni del dissenso dalla recente pronuncia della S.C. in Foro It., 24 agosto 2020.
[4] Cfr. R. Russo, Figli maggiorenni e mantenimento: la Cassazione cambia orientamento? Nota a Cass. Civ. (ord.) Sez. I, 16 luglio/14agosto2020, n. 17183, in GiustiziaInsieme,3settembre2020 https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-civile/1289-figli-maggiorenni-e-mantenimento-la-cassazione-cambia-orientamento
[5] Con tale intervento l’art. 374 cpc è stato modificato prevedendo tra l’altro che “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”.
[6] Che ha valorizzato i “precedenti” della Corte (art. 360-bis), prevedendo a tal fine l’istituzione di un’apposita sezione.
[7] Che ha ridotto i motivi di ricorso per cassazione concernenti l’accertamento di fatto del giudizio di merito, ripristinando il testo originario dell’art. 360 n. 5 ed escludendo, più radicalmente, la deducibilità di tale motivo in alcuni casi (art. 348-ter).
[8] Cfr. per un breve excursus sull’evoluzione legislativa in materia, La Cassazione civile vista dai suoi giudici - Recensione di Ernesto Lupo a “La Cassazione civile - Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana” (terza edizione, Bari 2020) a cura di Acierno, Curzio e Giusti in Giustizia insieme, 1 ottobre 2020, Intervista di F. De Stefano https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1318-la-cassazione-civile-vista-dai-suoi-giudici-recensione-di-ernesto-lupo-a-la-cassazione-civile-lezioni-dei-magistrati-della-corte-suprema-italiana-terza-edizione-bari-2020-a-cura-di-acierno-curzio-e-giusti
Come osserva E. Lupo nell’intervista citata, per effetto di questa evoluzione possono individuarsi due aspetti della Cassazione: quello relativo alla cassazione “dei casi singoli, che controlla la motivazione adottata dal giudice del merito” e quello attinente alla cassazione “dei principi di diritto”, che persegue l’unità della giurisprudenza e quindi la funzione di nomofilachia rivolta non al passato del caso singolo da decidere, ma essenzialmente al futuro dei casi analoghi da definire. La prima si esprime normalmente con ordinanze che decidono sui ricorsi che censurano la motivazione (degli accertamenti di fatto) o che pongono questioni di diritto la cui soluzione non implica l’esercizio della nomofilachia; la seconda pronunzia, invece, le sentenze attraverso le quali si esprime questa ultima funzione”.
L’obbligo di rimessione obbligatoria alle sezioni unite ogni qualvolta una sezione semplice ritenga di non condividere il principio di diritto da queste enunciato, è stato introdotto con le riforme del 2006 e del 2017 anche in considerazione delle difficoltà della Corte di cassazione (chiamata ad un tempo ad assicurare «l’esatta osservanza e l’uniformità dell’interpretazione della legge” in base all’art. 65 ord. giud., ed a svolgere il ruolo di giudice di terza istanza in base all’art. 111, comma 7, Cost.) ad assolvere alla funzione di “nomofilachia”. Cfr. al riguardo, anche per le conseguenze che ne sono derivate, E. Fidelbo, Il precedente nel rapporto tra sezioni unite e sezioni semplici: l’esperienza della Cassazione penale, in Questione Giustizia, fascicolo n. 4/2018 dal titolo Una giustizia (im)prevedibile? Il dovere della comunicazione
http://questionegiustizia.it/rivista/2018/4/introduzione-una-giustizia-imprevedibile-_572.php
Sulla nomofilachia cfr., tra gli altri, R. Rordorf, Magistratura Giustizia Società, Cacucci editore, Bari 2020, in particolare la parte IV dedicata “Corte di cassazione e nomofilachia”.
[9] Per rilievi critici sulla “cameralizzazione” cfr., tra gli altri, G. Costantino, Note sulle «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, in Il nuovo procedimento in cassazione, a cura di D. Dalfino, Giappichelli, 2017.
Le critiche rivolte alle eccessive limitazioni del contraddittorio nelle procedure camerali, in cui il legislatore ha escluso ogni possibilità di intervento orale dei difensori, sono condivise anche da E, Lupo, op.cit. il quale osserva come la scelta molto restrittiva del legislatore del 2016 può accettarsi soltanto come modalità utile a fare percepire agli operatori (magistrati ed avvocati), in modo evidente, la diversità tra i ricorsi da trattare in udienza pubblica (perché implicano l’esercizio della nomofilachia) ed i ricorsi da definire con procedura camerale (che interessano soltanto il caso concreto)”.
[10] G. Costantino, Introduzione, in Atti del XXXI Convegno nazionale dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, svoltosi a Padova il 29-30 settembre 2017, sul tema La tutela dei diritti e le regole del processo.
[11] E vedi, infatti, il commento all’ordinanza apparso su Altalex (Mantenimento del figlio maggiorenne: il cambio di rotta della Cassazione) ove si osserva che “un'innovativa decisione della Suprema Corte smantella una quantità di stereotipi giurisprudenziali, restituendo ai figli centralità e riconoscendo loro piena affidabilità”.
[12] Cfr. per una ricostruzione della fattispecie sottostante al ricorso su cui si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza in esame, R. Russo, op. cit.
[13] Cfr., ad es. il passo in cui si parla di permanenza del diritto (in relazione all'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, di un percorso formativo in fieri, ovvero in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione tale da assicurare l'indipendenza economica,) e l’altro passo in cui si afferma che, salva la prova di circostanze capaci di giustificare il permanere di un obbligo di mantenimento, il figlio maggiorenne non ne ha diritto, con ciò implicitamente ribadendosi che, allo scoccare della maggiore età, l’obbligo di mantenimento cessa fino a quando non sia data la prova dell’esistenza di circostanze idonee a farlo rivivere.
[14] Così R. Rordorf, op. cit., pag. 343.
Sul “peso” del precedente e sui modi in cui la giurisprudenza si pone rispetto ai precedenti propri cfr. lo stesso Autore, op. cit, pagg. 349-360, nonché - tra le altre - Cass. S.U. n. 23675/2014 e n. 13620/2012.
Con riguardo ai temi del valore del precedente, anche nel rapporto tra sezioni unite e sezioni semplici nonché nell’ambito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti; dell’overruling e della prevedibilità delle decisioni, della certezza del diritto; della giustizia “predittiva” ed altri temi connessi cfr. il fascicolo n. 4/2018 di Questione Giustizia, citato nonché tra gli altri, G. De Amicis, La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra sezioni semplici e sezioni unite penali della Corte di cassazione, in Diritto Penale Contemporaneo, 30 novembre 2018.
[15] P. Curzio, Il giudice e il precedente, in Questione Giustizia, fascicolo n. 4/2018, cit., il quale osserva come “il bilanciamento e il contemperamento di questi valori, è rimesso dal legislatore alla giurisprudenza, da intendersi, qui più che mai, come prudenza dei giudici”.
[16] Cr., per queste considerazioni, G. De Marzo, op. cit.
[17] Cfr., ad es. Cass. n. 30555/2019, ove si osserva come la figura dell'abuso del diritto possa reputarsi ormai “un principio immanente nel sistema”, volto “a fungere da adeguato strumento correttivo per le condotte giuridiche che - non confacendosi ai….principi di buona fede e correttezza, quali rivisitati alla luce dei principi costituzionali - tradiscono lo scopo e le finalità delle norme in virtù delle quali sono poste in essere”. Nel ricordare alcuni precedenti con i quali ha riaffermato l'operatività e l’esteso ambito di applicazione del principio, la Cassazione ha riassuntivamente osservato che si ha abuso del diritto “quando il titolare, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti”.
[18] G.De Marzo, op, cit.
[19] R. Russo, op. cit .
[20] Così R. Russo, op. cit., ove viene richiamato il passo della relazione illustrativa al d.lgs. n. 154/2013 in cui si osserva che “il concetto di responsabilità genitoriale è necessariamente più ampio, in quanto nella sua "componente" economica vincola i genitori al mantenimento dei figli ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino cioè al raggiungimento della indipendenza economica, come ormai pacificamente affermato nel diritto vivente”.
[21] Così l’ordinanza in commento.
[22] Come si legge nell’ordinanza (par. 4.2.1) “nessun rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore”, posto che il diritto e l'obbligo di cui si sta discutendo “si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato”.
[23] Che l’ordinanza in commento presume più agevole in capo al figlio: vedi, in contrario, le osservazioni di R.Russo, op. cit.
[24]Cfr. De Marzo, op. cit.
Come osserva R. Rosa, op. cit., sarebbe anche difficile qualificare “richiedente” il figlio che nel giudizio di revisione delle condizioni di separazione e divorzio non abbia spiegato neppure un intervento, e ancora di più il figlio divenuto maggiorenne nel corso di un giudizio di separazione o divorzio già instaurato.
[25] Così ancora, testualmente, De Marzo, op. cit.
[26] Il precedente nella giurisprudenza, op. cit. pagg.356-357

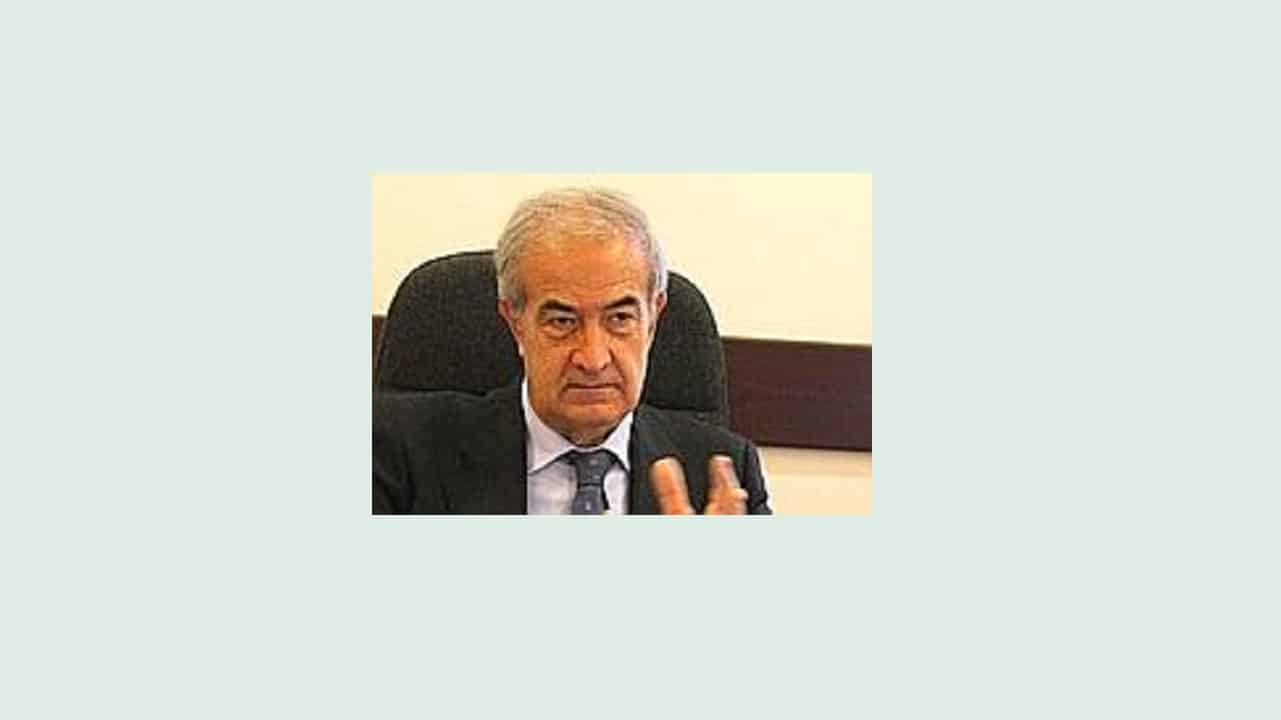

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.