La triangolazione penale retribuzione riparazione prescrizione*
di Angelo Costanzo
Sommario: 1. Retribuzione e prevenzione - 2. La giustizia riparativa - 2.1. Riparazione economica o sociale - 2.2. Riparazione nelle relazioni personali: la mediazione penale - 2.1.1. Stato emotivi e passionali e mediazione penale - 2.1.2. Mediazione penale e reati contro la famiglia - 2.3. Il reato riparato - 3. La cornice concettuale della pena prescrittiva.
1. Retribuzione e prevenzione
Le questioni relative allo scopo della pena sono cruciali per valutare la ragioni del processo penale e dell’istituzione penitenziaria, tanto più perché si possono constatare agevolmente sia la modesta efficacia delle sanzioni penali ai fini della prevenzione generale e speciale sia i molti riverberi negativi della pena carceraria, che peraltro riguarda principalmente le fasce marginali della società (così accrescendo disuguaglianze e emarginazione sociale), gli autori di gravi reati contro la persona e gli appartenenti alla criminalità organizzata[1].
L’idea della pena come retribuzione funzionale anche alla prevenzione di nuovi reati presuppone la pienezza del libero arbitrio e il suo prevalere sui vari condizionamenti che il mondo esterno e le emozioni o le passioni possono esercitare sulla volontà dell’individuo: si assume che l’imputato fosse in grado di comportarsi diversamente da come si comportò e si presume che la pena lo indurrà a agire in modo diverso nel futuro.
Sia la retribuzione che la prevenzione speciale concentrano le loro valutazioni essenzialmente sulla figura del reo e sulla sua condotta illecita (solo nei processi nei confronti di minorenni e nella fase esecutiva della pena questo orizzonte viene in qualche misura ampliato[2]). Tuttavia, dare attenzione al rapporto fra la vittima e il reo può giovare a entrambi (e anche alla società) se conduce a forme di mediazione e di riparazione distinte dalla tutela degli interessi patrimoniali che ordinariamente consente alla persona offesa di costituirsi in giudizio.
Indubbiamente la concezione della pena come afflizione proporzionata al reato commesso è solidamente radicata nella società e costituisce − anche nella prospettiva della tendenza alla rieducazione del condannato imposta dalla Costituzione italiana − il paradigma centrale nel sistema penale. Questo risulta palese dalle norme vigenti, che sono conformi alla tradizione giuridica, agli orientamenti culturali e ai valori morali (oltre che a intense propensioni irrazionali) prevalenti. Ma nulla osta a che la giustizia riparativa e la mediazione penale si sviluppino in termini di complementarità con il permanere delle sanzioni afflittive, cosicché gli oneri complessivi per il reo nel post delictum non differiscano, in linea di principio, da quelli derivanti da una pena meramente retributiva, salvo che per specifiche situazioni non si ammetta che un compiuto esito della riparazione possa tradursi in una condizione di sopravvenuta non punibilità.
2. La giustizia riparativa
Il 16 dicembre 2021 la Conferenza dei Ministri della Giustizia dei Paesi del Consiglio d’Europa ha redatto la Dichiarazione di Venezia, che invita il Consiglio d’Europa e gli Stati membri a considerare la giustizia riparativa non come un semplice strumento nell’ambito dell'approccio tradizionale alla giustizia penale, ma come espressione di una cultura più ampia che dovrebbe permeare il sistema di giustizia penale.
2.1. Riparazione economica o sociale
In realtà, l’ordinamento giuridico prevede già svariate forme di riparazione del reato che influiscono sulla pena o sulla stessa punibilità sino alla estinzione del reato (con il rischio, per il principio di eguaglianza, che i benefici per il reo derivino dalle sue condizioni economiche o, comunque, da condizioni contestuali e non soltanto dalle sue scelte personali) e ognuna delle periodiche commissioni di riforma del sistema penale ha di fronte la prospettiva di estendere il campo della giustizia riparativa[3].
2.2. Riparazione nelle relazioni personali: la mediazione penale
Tuttavia, il paradigma della giustizia riparativa prefigura qualcosa di più ampio rispetto al risarcimento del danno patrimoniale o sociale. Non è incompatibile con la giustizia retributiva, ma segue un altro percorso, che, mentre asseconda le esigenze della prevenzione speciale e della rieducazione del reo, si occupa della persona offesa dal reato.
La mediazione fra il reo e la persona offesa riguarda propriamente i reati che ledono le persone nella loro dimensione psicologica e morale e si collega a un’idea di responsabilità che è indipendente da quella che il reo ha verso lo Stato e che non è retrospettiva (rivolta alla precedente condotta riprovevole) ma prospettica (rivolta a quel che di positivo si può fare nonostante la commissione del reato)[4].
Viene considerata la dimensione diacronica e relazionale del reato e delle sue conseguenze. Si mira a fare evolvere i rapporti in una loro estensione cronologica più ampia di quella (a volta prolungata, altre volte circoscritta a pochi istanti) in cui si colloca il comportamento penalmente rilevante, utilizzando l’oblio attivo, cioè la capacità di distaccarsi dal passato per attenuarne le conseguenze dannose. Si guarda alla vicenda complessiva nella sua realtà, nella sua durata[5].
La pena retributiva segue un criterio di proporzionalità che si concretizza nella determinazione della sanzione ma le sue conseguenze ulteriori non sono prevedibili (neanche la sua estensione cronologica è compiutamente determinata perché possono sopravvenire benefici che la riducono o cumuli che la accrescono).
Invece, le procedure di mediazione penale mirano a produrre uno specifico risultato tangibile che ricomponga in qualche modo, sia dal punto di vista del reo che dal punto di vista della vittima, lo squilibrio relazionale provocato dal reato.
L’idea della giustizia riparativa valorizza una spiegazione del reato che non si limita alla valutazione di una scelta individuale illecita ma si estende alla considerazione delle condizioni (a volte semplici, spesso complesse) che la favoriscono.
Esistono variegate forme e diversi fattori (economici, politici, psicologici) di corresponsabilità sociale nella produzione dei reati e certamente sanzionare l’individuo risulta più semplice che controllare questi fattori. Allora risulta chiaro che la giustizia riparativa veicola idee diverse rispetto a quelle che reggono la concezione della pena come afflizione proporzionata al fatto commesso, ma questo non rende incompatibili le loro rispettive applicazioni.
La concezione corrente considera il reo per le sue condotte ma trascura quel che persona offesa può, in varie forme (desiderio di vendetta, semplice rabbia o rancore, recriminazioni verso gli altri e verso noi stessi) provare per avere patito una condotta criminale. Invece, la mediazione penale considera la vittima anche come un destinatario degli effetti della incapacità dell’autore del reato di risolvere in modo positivo i suoi conflitti interni o con l’ambiente sociale. Mira a fare regredire la dimensione conflittuale del rapporto fra il reo e la vittima soprattutto mediante la rivisitazione degli accadimenti, l'evoluzione delle rispettive posizioni e una reinterpretazione del fatto che non li trovi più soltanto come soggetti in contrasto.
Evidentemente la riparazione del reato non può essere regolata da criteri generali e astratti. Tuttavia, va risolta normativamente la questione della collocazione istituzionale della figura del mediatore e della sua attività nel sistema processuale perché il suo ruolo, tanto essenziale quanto delicato, non consiste solo nel comporre il conflitto fra il reo e la vittima, ma sta anche nel valutare preliminarmente se esistono le condizioni perché ciò avvenga[6].
2.1.1. Stato emotivi e passionali e mediazione penale
A volte può risultare in concreto difficile accertare e valutare lo stato psichico della persona al momento in cui compì il reato (così da condurre il diritto penale italiano a considerare in linea di principio irrilevanti gli stati emotivi e passionali e i loro andamenti), distinguere tra normalità e patologia, registrare i meccanismi dei processi mentali e, così, riaffermare solidamente la validità che principio che fonda la responsabilità giuridica in termini soggettivi.
La giustizia riparativa si adatta particolarmente a questo genere di situazioni perché valuta la relazione fra la responsabilità individuale e la sanzione afflittiva come eventuale e non necessaria. Infatti, dal punto di vista della giustizia riparativa (non anche del suo combinarsi con quella retributiva) il nucleo della responsabilità soggettiva sta nel dovere di rispondere alla persona offesa per ciò che si è compiuto a suo danno. La risposta può anche non essere immediata ma concludere un itinerario che si svolge in un tessuto di relazioni che supera la diade reo-vittima e si muove nell’ambito della triade reo-mediatore-vittima nel contesto del rapporto Stato-reo.
2.1.2. Mediazione penale e reati contro la famiglia
La proposta (comunque già concretizzarsi nella evoluzione della giurisprudenza) della dottrina penalistica di ricollocare i reati contro la famiglia nell’ambito dei reati contro la persona agevola previsioni di mediazione soprattutto relativamente ai reati di maltrattamenti e di violazione degli obblighi di assistenza morale, per le implicazioni di carattere affettivo e psicologico che essi naturalmente presentano. Se ne hanno anticipazioni già nella sentenza della Corte costituzionale n. 357 del 20/07/1990.
In particolare, per quel che riguarda i maltrattamenti, ridurre la pena massima edittale a quattro anni (nella pratica raramente le pene sono inflitte in questa misura e, per lo più, sono inferiori ai due anni e sospese) consentirebbe la applicazione del procedimento della messa alla prova dell’imputato ex art. 168-bis cod. pen.
2.3. Il reato riparato
Sarebbe utile una raccolta compilativa delle forme riparatorie speciali (che hanno prodotto una parziale decodificazione) e delle oblazioni (frequenti in materia di contravvenzioni), perché potrebbe condurre a giustificare l’idea di una figura di parte generale del delitto riparato che riduca la pena originaria in rapporto alla riparazione dell’offesa; oppure l’avvenuta riparazione come un titolo autonomo di reato (il reato riparato con una sua pena indipendente, simmetricamente a quel che avviene con la figura del tentativo di reato).
Al riguardo è stata proposta una disequazione: delitto riparato uguale o minore al diritto tentato, “delitto riparato ≤ delitto tentato, seguendo l’idea che il disvalore e il trattamento punitivo del delitto riparato siano o meno gravi, o equivalenti a quelli del tentativo. In quest’ottica la previsione della diminuzione della pena fino a due terzi non deriverebbe dalla configurazione di una circostanza attenuante ma da un titolo autonomo di reato: il reato riparato quale analogo inverso rispetto al reato tentato[7]. Oppure il legislatore potrebbe determinare per alcuni reati, o per categorie di reati, non soltanto le sanzioni edittali ma anche i possibili strumenti riparatori connessi.
3. La cornice concettuale della pena prescrittiva
3.1. Il diritto penale deve essere giustificato sulla base di scelte valoriali fondate su principi ben intellegibili e fra loro coesi e le idee relative alla giustizia riparativa riattualizzano le questioni relative alla scopo della norma penale.
Se la pena retributiva non è più vista come unica forma di pena perché le si affianca la (eventuale) riparazione delle conseguenze del reato, allora occorre una cornice concettuale sovraordinata che ricomprenda sia la retribuzione che la riparazione, in un misto di afflizione e (eventuale) riparazione verso la collettività e/o le persone lese.
Questa cornice è offerta dalla pena prescrittiva intesa come pena principale, all’interno della quale restrizioni personali afflittive (dalle diverse forme di limitazione della libertà personale alla interdizione allo svolgimento di attività) e prescrizioni di condotte attive (anche riparatorie) possono variamente equilibrarsi secondo i tipi e la gravità dei reati, ma sempre in base a previsioni tassative nel necessario rispetto del principio di legalità delle pene e al fine di indirizzare e circoscrivere la discrezionalità dei giudici[8].
Una pena prescrittiva contenuta ma rapida − a conclusione di processi snelli nei quali siano comunque assicurate le garanzie procedurali essenziali − può risultare più efficace, con effetti personali e con impegno sociale meno drammatici, nel ridurre i rischi di recidiva, soprattutto nei casi di reati di lieve o media gravità, invece di una pena più estesa e posticipata nel tempo quando le condizioni del soggetto e del suo contesto) potrebbero essere mutate (e risultare accresciuta o, all’inverso, ormai scemata la sua tendenza a delinquere) oppure la sua stessa attuabilità potrebbe evaporare per effetto della prescrizione del reato[9].
Peraltro, una pena siffatta (vicina nel tempo al reato contestato e breve nella sua durata) renderebbe meno nefasti gli effetti di sempre possibili errori giudiziari.
3.2. I modelli di giustizia riparativa e prescrittiva derivano da elaborazioni criminologiche o da approcci empirici e esperienziali.
Invece, la materia richiede appositi approfondimenti scientifici e una sua correlata autonomia didattica nei programmi accademici, che tenga conto anche degli apporti della vittimologia, disciplina che tratta la tipologia delle vittime e il loro ruolo nella genesi del crimine, e comporta una specifica formazione professionale per i giuristi giudiziari[10].
Serve anche a una tecnica legislativa che delimiti i poteri discrezionali del giudice, il cui compito risulterebbe più agevole se il legislatore si limitasse a dare rilievo a forme materiali (oggettivabili) di riparazione, mentre sarebbe troppo largo (e potrebbe sforare in modi debordanti dai suoi limiti istituzionali) se fossero ammesse anche forme di riparazione per equivalente o a carattere ideale o simbolico.
*Relazione svolta il 10/011/2021 presso il Centro di ricerca sulla Giustizia dei minori e della famiglia dell’Università di Catania.
[1] Sul tema l’incontro organizzato a Napoli dalla Scuola Superiore della Magistratura il 14-16 luglio 2021 dal titolo Dalla giustizia sanzionatoria alla giustizia riparativa.
[2] G. Tuccillo, Linee di indiritto del Dipartimento per la Giustizia minorile in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato. Ministero della Giustizia minorile e di comunità, in: Giustizia News on line, Quotidiano del Ministero della Giustizia, 22 maggio, 2019.
[3] Ne sono esempi: lo scioglimento della cospirazione e della banda armata (artt. 308 e 309), la ritrattazione nei reati contro l'amministrazione della giustizia; l'adempimento che estingue l'insolvenza fraudolenta. L’art. 162-ter cod. pen. per i reati procedibili a querela soggetta a remissione prevede la estinzione del reato nel caso di riparazione integrale del danno causato (lo schema di una forma processuale della mediazione penale sta nell’art. 29 d.lgs. n. 274/2000 relativo ai reati di competenza del giudice di pace). Per il d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti l'eliminazione delle conseguenze pericolose e dannose del reato e il risarcimento integrale conducono alla esclusione delle pene interdittive e alla riduzione di quelle pecuniarie. Dal 2002 esistono, in materia societaria, forme di risarcimento che estinguono il reato (artt. 2627, 2628, 2633 del codice civile riformato). Similmente il pagamento del debito tributario, la riparazione integrale del danno prodotto dall’inquinamento idrico, la riguardante la bonifica dei siti producono a benefici per il reo. Relativamente alla criminalità organizzata sono previsti premi per la collaborazione poi estesi alla criminalità comune. La collaborazione processuale rileva nei reati contro il diritto d'autore, nel contrabbando, nel furto e nella ricettazione, nell'immigrazione clandestina, nella riduzione in schiavitù, nella tratta di schiavi, in materia di pedopornografia, di proprietà industriale e di reati relativi ai prodotti agroalimentari. L’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. prevede una riduzione della pena nel caso di riparazione integrale del danno prima del giudizio o dell’adoperarsi, fuori dal giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato. Nel codice penale alcuni istituti sono combinati al risarcimento: la seconda sospensione condizionale, l’amnistia e gli indulti condizionati, i condoni tributari, previdenziali, urbanistici.
[4] La materia è ormai estesamente e variamente trattata. Per un approccio lucido, fra gli altri: V. Patanè, Mediazione penale (voce), in: Enciclopedia del diritto, Annali II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008; V. Patanè, La tutela della vittima nel procedimento di mediazione, in: Giurisprudenza italiana, 2012, 2,485 (commento alla normativa); R. BARTOLI, Il diritto penale tra vendetta e riparazione, in: Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 2016, pp. 101ss; G. Mannozzi, Giustizia riparativa, in: Enciclopedia del diritto, Annali, X, 2017, pp. 475.
[5] Inevitabile il richiamo al pensiero di Bergson e, in particolare al suo Essai sur less données immédiates de la conscience del 1889 (trad.it. di F. Sossi, Saggio sui dati immediati della coscienza, in Opere, 1889-1896, Milano, Mondadori, 1986). Vale citare anche: R. Ronchi (a cura di). H Bergson- W. James, Durata reale e flusso di coscienza. Lettere e altri scritti (1902-1939), Milano, Raffaello Cortina, 2014.
[6] La mediazione autore-vittima ha terreno fertile nell’ambito della giustizia minorile (gli artt. 9, 27 e 28 del d.P.R. 448/1988 consentono alla mediazione di svolgere un ruolo in relazione agli istituti della tenuità del fatto e della sospensione del processo con messa alla prova) e potrebbe trovarlo anche in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, dove è previsto l’obbligo per il giudice di promuovere la conciliazione fra le parti, la non procedibilità per particolare tenuità del fatto e l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (artt. 29, co. 4, 34 e 35 d.lgs. n. 274/2000). Nell’ordinamento penitenziario l’affidamento in prova ai servizi sociali ha connotati riparativi (art. 47 l. n. 354/1975), perché prevede la possibilità per l’affidato di adoperarsi in favore della vittima del reato, con effetti riparativi e risocializzanti.
Con la legge del 28 aprile 2014 n. 67 è stata introdotta la sospensione del procedimento con messa alla prova, che configura uno spazio di concreta operatività per mediazione. Invece, la legge 27 settembre 2021 n. 134 «Delega al Governo per l’efficienza del processo pena nonché in materia di giustizia riparativa» coltiva una prospettiva più ristretta e introduce una modifica dell’art. 165 cod. pen. che ampia i casi in cui la sospensione condizionale della pena può essere subordina alla riparazione del danno o a prestazioni gratuite in favore della collettività o alla partecipazione a percorsi di recupero del condannato.
[7] M. Donini, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in: Diritto penale contemporaneo, 2, 2015, pp. 236 ss.
[8] L. Eusebi, Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale, relazione introduttiva in: Dalla giustizia sanzionatoria alla giustizia riparativa. S.S.M.N. 14-16 luglio 2021, Napoli, Castel Capuano.
[9]Per i reati meno gravi, si potrebbero aumentare le ipotesi di messa alla prova (art. 168-bis cod. pen.) e, per quelli più gravi, dove una esecuzione anche detentiva sarebbe inevitabile, di aumentare comunque le ipotesi di pene alternative al carcere. In Italia i limiti edittali inferiori delle pene sono elevati e impediscono di individualizzare la pena, sebbene criteri dell’art. 133 cp, siano tutti diretti alla individualizzazione, e quindi opposti alla prevenzione generale. In Francia non c'è il minimo edittale, ma solo il massimo; in Germania dei minimi bassissimi, tranne che per i delitti più gravi.
[10] G. Mannozzi- GA. Lodigiani, Formare al diritto e alla giustizia: per un’autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario, in: Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1, 2014, pp.

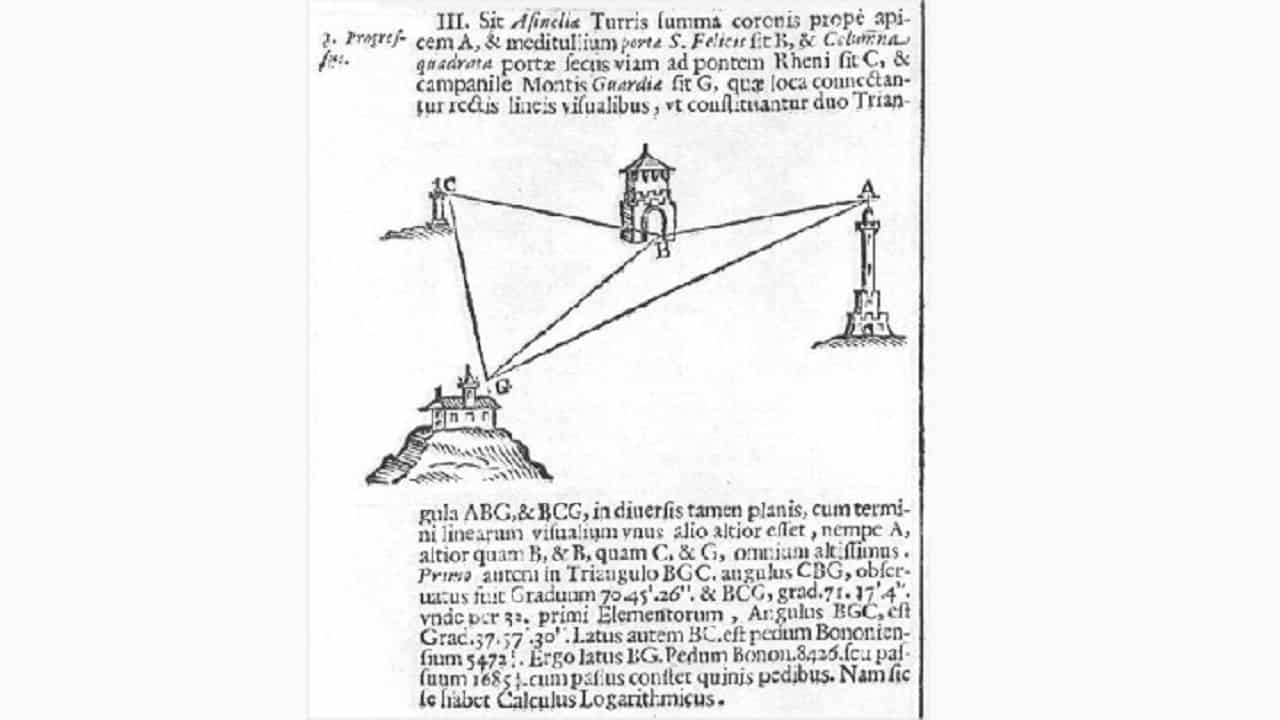

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.