Dopo aver indagato il tema della comunicazione, oggetto della rubrica della Rivista presentata con l’editoriale del 18 maggio 2021 attraverso il pensiero della magistratura di legittimità e di merito (si rimanda ai contributi di Gianni Canzio, Giovanni Melillo, Claudio Castelli) ed aver approfondito il valore della comunicazione e della parola quale mezzo di emancipazione dell’individuo e della società grazie allo scritto di Francesco Messina passando per un’analisi del tema del linguaggio dell’Accademia con Marina Castellaneta e della questione cruciale della comprensibilità e della conoscibilità dell’attività giurisdizionale attraverso il pensiero di Marcello Basilico, Giustizia insieme ha dedicato una serie di interviste ai professionisti della comunicazione e, facendo seguito a quelle di Rosaria Capacchione, Giovanni Bianconi, sono stati coinvolti i giornalisti Claudia Morelli e Giovanni Tizian
È seguito l'approfondimento di Edmondo Bruti Liberati sul drafting relativo all'attuazione della dir.UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza- La problematica attuazione della direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza-.
Oggi è la volta dell'Avvocato David Cerri, con un contributo dedicato alla comunicazione dell'Avvocato.
Giustizia e comunicazione. 12) La comunicazione dell’avvocato
di David Cerri
Sommario: 1. La comunicazione dell’avvocato - 2. La comunicazione delle associazioni - 3. La comunicazione delle istituzioni.
1. La comunicazione dell’avvocato
Argomento non semplice: già il titolo è equivoco. Perché dell’avvocato, e non degli avvocati o dell’avvocatura? Si tratta evidentemente di punti di vista differenti. C’è poi un’altra premessa da fare: chi scrive rappresenta solo se stesso, non ha certamente la pretesa di esprimere l’opinione dell’intera avvocatura italiana, nè di una sua parte presunta maggioritaria, tantomeno delle sue istituzioni.
Messo in guardia il lettore, affrontiamo comunque il tema, iniziando dal profilo citato per primo: la comunicazione del singolo professionista o del singolo studio richiama subito alla mente quella che di solito si definisce come la “pubblicità”. Si dica allora che questo tema, affacciatosi prepotentemente alla ribalta anche delle professioni forensi italiane negli ultimi anni, sulla scia di un facile entusiasmo per esperienze di altri ordinamenti (non ben conosciute né intese) alla prova dei fatti si è rivelato scarsamente interessante. Chi abbia infatti studiato come la questione della pubblicità dell’avvocato ci sia evoluta in ordinamenti come quello statunitense, dopo celebri sentenze della Corte Suprema degli anni ‘70, e faccia poi un paragone con l’attualità italiana, si rende subito subito conto di come la diversità non solo e non tanto degli ordinamenti, quanto piuttosto del contesto giuridico, delle relative tradizioni, e soprattutto dell’ambiente sociale ed economico abbia fatto sì che l’uso che se ne fa in quel paese (e anche in altri paesi europei, sia pur con tutt’altre modalità) non sia paragonabile né per qualità né per quantità alla nostra più recente esperienza. La motivazione a mio parere è piuttosto semplice: nel contesto eurounitario limitazioni alla concorrenza, anche sotto il profilo delle comunicazioni commerciali, sono ben previste (e direi a maggior ragione nelle professioni regolamentate rispetto alle imprese) in nome della tutela del pubblico interesse. La direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkenstein, espressamente ci rammenta all’art. 24 che “Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate”; se si legge come se ne è fatta applicazione in Italia col D.Lgs. n.59 del 2010 (art.34, c.3): “I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione, nonche' il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione” si vede inoltre come subito di seguito la norma si concluda con la pedissequa ripetizione del principio adottato in sede europea poco sopra riportato.
È questo infatti un caso esemplare nel quale la normativa deontologica aiuta l’ interpretazione e l’applicazione della legge statale. Il codice deontologico forense prevede all’art.17 in primo luogo il carattere essenziale della pubblicità dell’avvocato in Italia: quello informativo, e non meramente commerciale. L’art. 35 dettaglia poi l’applicazione di quel principio, i cui canoni sono quelli già conosciuti dalle discussioni sulle comunicazioni commerciali: trasparenza, veridicità, correttezza, non equivocità, non ingannevolezza, col divieto di informazioni denigratorie, suggestive o comparative.
Non è una singolarità del nostro ordinamento, perché lo stesso C.C.B.E., nel suo codice richiama all’art.2.6, 1 i criteri della veridicità e della correttezza, nonché i principi fondamentali della professione, sempre (come si ricava dall’intero sistema del codice e dal suo preambolo) a tutela del superiore pubblico interesse della tutela della collettività, mediante l’espresso riferimento allo “stato di diritto” ed alla “buona amministrazione della giustizia”; se si vuol declinare il termine di collettività in altro modo (francamente meno coinvolgente, a tacer della diversità ontologica) precisiamo allora: del consumatore.
Ancor meglio l’indagine svolta dalla Commissione sulla Concorrenza dell’ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - O.C.S.E. (DAF/COMP/(2007)39) sulle restrizioni alla concorrenza nel settore legale, ha infatti evidenziato il fenomeno dell’adverse selection, cioè che a far maggior ricorso alla pubblicità sono i legali che mostrano di avere la minore qualità; ed ha affermato a chiare lettere che “la nozione di pubblico interesse è più ampia della necessità di correggere i difetti del mercato”, per concludere che tra gli argomenti a favore di (proporzionate) limitazioni alla pubblicità si staglia quello di “Prevent charlatans from obtaining business”… che non ha bisogno di traduzione.
Singolari e fortemente contestate dei professionisti sono state quindi, e comprensibilmente, le interpretazioni offerte dall’A.G.C.M. che in numerosi interventi ha avuto modo di ritenere assurdo il riferimento a criteri come decoro e dignità, propri invece di tutti gli ordinamenti professionali in Italia, in Europa, ed in generale non solo nel mondo delle democrazie occidentali. Assurdo, al contrario, mi è sempre parso voler identificare tout court le professioni forensi con il mondo delle imprese, in particolare per la paradossale conseguenza che a seguire quei ragionamenti ne risulterebbe che i clienti degli avvocati dovrebbero avere meno tutele dei clienti delle imprese, alle quali codici del consumo come quello italiano, direttive eurounitarie, strumenti di autoregolamentazione delle aziende consentono invece una tutela consolidata anche in normative direttamente applicabili (pensiamo soltanto alla disciplina delle comunicazioni ingannevoli). Anche tali punte polemiche, peraltro, sono andate stemperandosi di fronte alla costatazione - fatta propria in primo luogo dalle stesse principali agenzie pubblicitarie -che di queste modalità di marketing (concetto ben più ampio) gli avvocati italiani hanno fatto ben scarso uso; e se, come accennato all’inizio, parlare degli avvocati italiani in generale può sembrare un’affermazione troppo generica e totalizzante, diciamo meglio allora: della stragrande maggioranza di loro; le grandi law firms, le cui case madri sono spesso di matrice estera, in realtà dal punto di vista professionale ed in particolar modo sociologico hanno molto poco a che fare con l’avvocato come la maggior parte di noi lo conosce. Basterebbe leggere le cronache di questi giorni a margine dell’arbitrato Rizzoli/RCS, con le colorite descrizioni dei professionisti dei grandi studi che vi hanno partecipato, per rendersene meglio conto. Una dimostrazione è data ripetutamente dalle indagini del Censis, che continuano a registrare anche di recente come il principale strumento di acquisizione della clientela sia il cosiddetto passa parola. Tutto ciò non significa ignorare I tentativi, spesso un po’ penosi, di pubblicità fatta in casa da numerosi studi: basta una veloce carrellata in rete per rendersene conto. C’è molto da dubitare però che tali tentativi diano dei frutti consistenti, senza naturalmente voler qui considerare le limitazioni di natura normativa e deontologica pur esistenti. Anche a questo proposito, però, torna decisivo il richiamo al pubblico interesse, che dovrebbe essere meglio apprezzato proprio considerando l’esperienza degli ordinamenti che assai prima del nostro hanno riconosciuto questa possibilità ai professionisti. Mi piace allora ricordare quanto mi riferiva il professor Settis, notissimo storico dell’arte, nel corso di un’intervista di qualche anno fa per una rivista giuridica che curavo. A proposito della sua esperienza di amministratore del Getty Museum a Malibu - esperienza che lo portava naturalmente a contatti con grandi studi professionali di Los Angeles - il professore mi riferiva parlando di questi temi che proprio uno dei suoi interlocutori gli raccontava con una certa amarezza come il regime di ampia libertà nella rappresentazione pubblicitaria dei professionisti californiani provocasse un grave danno sociale a carico delle categorie meno dotate di strumenti per interpretare correttamente una reclame televisiva, un cartellone affisso in autostrada, un annuncio fatto su un giornale o su internet. In particolare vittime di professionisti con pochi scrupoli erano, a detta di quel legale, gli immigrati ispanici di recente ingresso, che cadevano vittime della scarsa conoscenza delle consuetudini statunitensi, affidandosi così inutilmente, se non con danno, ad avvocati che ricordavano il famoso Lionel Hutz dei Simpson (se vi ricordate, è quello il cui motto è “Cause vinte in 30 minuti o pizza gratis!”, e che Lisa Simpson definisce uno “schyster”, termine che non oso tradurre ad un uditorio raffinato come quello di questa Rivista. In effetti uno sguardo su quel mondo è piuttosto interessante, se lo si vede come una possibile anticipazione di quello che sarebbe potuto accadere anche in Europa e in particolare in Italia ove non ci fosse una cura particolare della tutela della collettività di fronte agli operatori economici, di ogni tipo, miranti esclusivamente ricavare un profitto dalle loro attività. In altre parole nessuna regola significherebbe averne una sola: massimo profitto col minimo sforzo, il che, mi si consentirà, non è la migliore soluzione. A pensar diversamente sono rimasti gli epigoni del momento d’oro del neoliberismo selvaggio.
La comunicazione informativa, allora: segue agevolmente ed in primo luogo anche nel nostro paese i canali internet, spesso senza dover ricorrere a specifiche professionalità tecniche (e si vede…); si attua prevalentemente con la presentazione dei siti degli studi, delle informazioni utili per la scelta del professionista, nonché di tutte quelle altre indicazioni di tipo pratico (un esempio banale, la sede dello studio con suggerimenti per raggiungerlo, i parcheggi, e così via); naturalmente le aree di prevalente attività dei professionisti (vedremo poi l’uso che sarà fatto dei titoli di specializzazione, quando anche questa possibilità sarà ampiamente sfruttata; sin d’ora mi sentirei di dire che i risultati, sotto questo profilo, saranno minori di quelli forse attesi, per il semplice fatto che la realtà italiana vede una miriade di studi composti da pochi professionisti, una diffusione sul territorio capillare (anche in relazione all’elevato numero di fori), ciò che comporta che il fregiarsi del titolo di specialista in un dato ambito potrebbe in realtà avere l’effetto controproducente di escludere l’ interesse del potenziale cliente sotto tanti altri profili, magari egualmente trattati dal medesimo professionista con apprezzabile competenza, benchè non “bollinata”: staremo a vedere.
C’è infine, anche un altro tipo di pubblicità formalmente informativa ma sostanzialmente commerciale: quella delle interviste fasulle, fenomeno non così irrilevante se alcuni Ordini territoriali avevano sentito già da tempo l’opportunità di dotarsi di apposite delibere sull’argomento. Questione peraltro superata – da chi se lo può permettere – con gli interventi più sinceramente sfacciati su riviste nate ad hoc, di solito patinate, e che mi spingono a ricordare il titolo dell’opera del critico formalista russo Viktor Šklovskij, Il punteggio di Amburgo, e la sua spiegazione: “Il punteggio di Amburgo è importantissimo. Tutti gli incontri di lotta sono truccati. Gli atleti si fanno mettere con le spalle a terra secondo le istruzioni dell’impresario. Ma una volta l’anno si riuniscono ad Amburgo in una osteria e lottano a porte chiuse, con le tende tirate.
Lottano a lungo, con ostinazione, senza eleganza. Il punteggio di Amburgo serve a stabilire la classe reale di ciascun lottatore e ad evitare il totale discredito. Anche in letteratura non se ne può fare a meno” concludeva Šklovskij, e neppure nel nostro ambito. Ed i migliori giudici sono anche per noi i colleghi, cui potrebbero aggiungersi i magistrati, seguendo l’esempio di altre formule, come Find a Lawyer della Law Society of England and Wales, fondate sul peer review.
2. La comunicazione delle associazioni
Finora ho cercato di tratteggiare la comunicazione tesa in gran parte all' acquisizione ed alla cura della clientela, e pertanto dal punto di vista del singolo studio; gli avvocati però, associati nelle loro forme di aggregazione, tendono a svolgere anche altri tipi di comunicazione, che solo in parte possono essere ricondotti ad una forma di “pubblicità di categoria” e/o della stessa singola associazione. In questa prospettiva gli interessi che si vogliono coltivare sono sovente, ed in linea generale, quelli della tutela della stessa categoria, se si vuole in un' ottica sindacale (più frequente per alcune e minore in altre), con un particolare interesse alle esigenze degli iscritti al singolo ente, di solito riunitisi per la comunanza dell’ attività prevalentemente svolta. Tra le associazioni specialistiche formalmente riconosciute come “maggiormente rappresentative“ in attuazione del Regolamento n.1/013 C.N.F., di applicazione dell’articolo 35 c.1 lett. s) L. n. 247/2012, si annoverano alcune tra le più note – come (sperando di non suscitare reazioni da parte delle altre che non ricorderò solo per motivi espositivi…) le Unioni delle Camere Penali e delle Camere Civili, e le diverse di avvocati della famiglia (come AIAF, ONDIF, Cammino ecc.) e del lavoro (come AGI); ma non mancano associazioni “generaliste” che vantano una diffusione capillare sul territorio, come - una per tutte - l‘AIGA. Ebbene, quelle di maggiori dimensioni ed “anzianità” godono di veri uffici stampa, che ne permettono la costante presenza non solo nella pubblicistica di settore, ma anche nella opinione pubblica, tramite frequenti e mirati interventi sui quotidiani di maggior notorietà sui temi dell' attualità politica e sociale. Un altro profilo, attentamente curato dalle associazioni - e che costituisce buona parte delle loro attività di proselitismo – è quello della formazione continua, dove l' allestimento di convegni ed incontri di studio costituisce non solo un importante mezzo di accrescimento culturale dell’intera categoria, ma indubbiamente anche uno strumento di promozione della singola associazione: mentre si rende un servizio, quasi sempre poco costoso se non gratuito , ci si presenta ai colleghi in termini di efficienza ed aggiornamento. Già la parzialissima enumerazione delle diverse associazioni fa comprendere come la comunicazione dei professionisti forensi italiani non sia comparabile con quella di altri operatori della giustizia, come i magistrati, che oltre ad avere regole dettate dal legislatore, per l'ovvio rilievo pubblico della loro funzione, hanno anche organi di autogoverno che consentono l'adozione di regole; regole che almeno nella loro ispirazione dovrebbero indirizzare i comportamenti dei membri di quell’ordine (penso anche soltanto alle Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale adottate dal CSM nel 2018). L’avvocatura, pur essendo una professione regolamentata, con la costituzione di un organo apicale e di organi territoriali regolati dalla legge, non ha certamente (in primo luogo forse per le sue dimensioni) la possibilità di esprimere con una sola voce le sue indicazioni: ciò che nel contempo è un male, per la sicura minore efficacia, ma anche un bene, perché le diverse opinioni vengono alla luce del sole ed a conoscenza diretta dell'opinione pubblica. Quest'ultima riflessione ci porta diritto all'ultimo paragrafo di questo intervento.
3. La comunicazione istituzionale
Le istituzioni forensi, in Italia, come tutti sanno sono regolate dalla legge, e non da oggi ma dal 1874, con la tragica parentesi fascista. La loro natura di organi pubblici è causa ed insieme effetto del loro ruolo; non ci si associa liberamente all’Ordine di appartenenza, ma lo si deve fare, perché il legislatore – in ossequio, oggi, ai principi costituzionali – ha ritenuto che dovesse essere assicurato alla collettività l’affidamento in professionisti “verificati” (con tutte le debolezze delle “verifiche”, delle quali non è questa la sede per parlare), aggiornati e corretti, svolgenti un ruolo sociale ineliminabile (almeno nelle nostre democrazie). Può quindi apparire non scontato che tale istituzioni svolgano, oltre a quella definibile come una consueta comunicazione istituzionale, (relativa alle informazioni necessarie allo svolgimento della professione – a livello locale e nazionale - , ai servizi per i cittadini, ai rapporti con gli altri protagonisti del sistema giustizia) un intervento più esplicito, destinato ad influenzare direttamente l’opinione pubblica e la politica. Sarebbe però veramente ingenuo pensare che, data l’occasione, essa non venga colta, al pari di quello che fanno gli altri operatori. Questa è la strada che da alcuni anni ha intrapreso anche il Consiglio Nazionale Forense, dapprima con il ricorso (non troppo felice) alla collaborazione di agenzie specialistiche, poi con l’iniziativa del quotidiano Il Dubbio, nato nel 2015 tra le polemiche di buona parte dell’avvocatura. Polemiche spesso dettate dai costi non modesti dell’impresa, ma anche da una contrarietà di fondo ad esprimere una presenza in senso lato “politica” della categoria, da riservare piuttosto, secondo alcuni ed in una prospettiva sindacale, alle libere associazioni. Non starò qui certamente a fare la storia dei rapporti tra C.N.F. ed O.U.A., prima, e O.C.F., dopo (sigle per iniziati che, appunto, sarebbe troppo lungo spiegare) ma oggi è innegabile che, nel succedersi di direttori (aveva iniziato Sansonetti) che hanno dato una propria impostazione alla pubblicazione, questa sia entrata di diritto tra quelle citate d’obbligo nelle rassegne stampa; conseguenza forse inevitabile della perenne querelle sullo stato comatoso della giustizia italiana, la cui lettura semplificata vede additare come responsabili ora la magistratura, ora l’avvocatura, ora l’esecutivo di turno, e spesso tutte e tre.
Di sicuro questo tipo di pubblicazione può contribuire alla crescita culturale della categoria ed insieme del paese (ho in mente, per esempio, interventi recenti e posti in adeguato risalto sulla lingua di genere, di Barbara Spinelli e Stefania Cavagnoli); si può essere più perplessi nell’insistenza da un lato su temi dell’attualità “spicciola” e, dall’altro, su battaglie capitali come quella per “l’introduzione dell’ avvocato in costituzione” (personalmente credo che l’avvocato ci sia già, eccome, e che forse è nella normativa ordinaria che dovrebbero essere apprestate più adeguate tutele e soprattutto risorse: ma – al solito: ormai lo si sarà capito come la penso…– nell’interesse principale della collettività, non in quello della categoria, che ne risulterà garantito di riflesso).
Ricordo infine come, al pari delle associazioni, e come ho già ricordato, anche le istituzioni forensi a tutti i livelli si presentino all’interno ed all’esterno della categoria con l’attività svolta per la formazione, tanto per l’accesso che continua. Un professionista competente per far fronte ai suoi obblighi necessita di una formazione iniziale e di un aggiornamento continuo di alto livello; non è un caso che con la dismissione dei poteri dei poteri disciplinari in favore dei nuovi Consigli Distrettuali gli Ordini territoriali abbia visto crescere esponenzialmente le iniziative formative, spesso tramite la costituzione di appositi enti (come le numerose Fondazioni) che danno continuità a strutture organizzativamente complesse, assai spesso in proficua collaborazione con le Università (anche indipendentemente dall’esistenza di apposite convenzioni) ed assicurandone la “tendenziale gratuità” richiesta. E’ questa attività formativa (anche per il coinvolgimento interdisciplinare di altre professioni e della magistratura, per quello di altre istituzioni pubbliche, e talvolta caratterizzata anche dall’apertura alla cittadinanza: un esempio le manifestazioni per la Giornata della Memoria) che mi pare costituisca il miglior biglietto da visita dell’avvocatura italiana, ed in ogni caso la forma di “comunicazione” che prediligo.

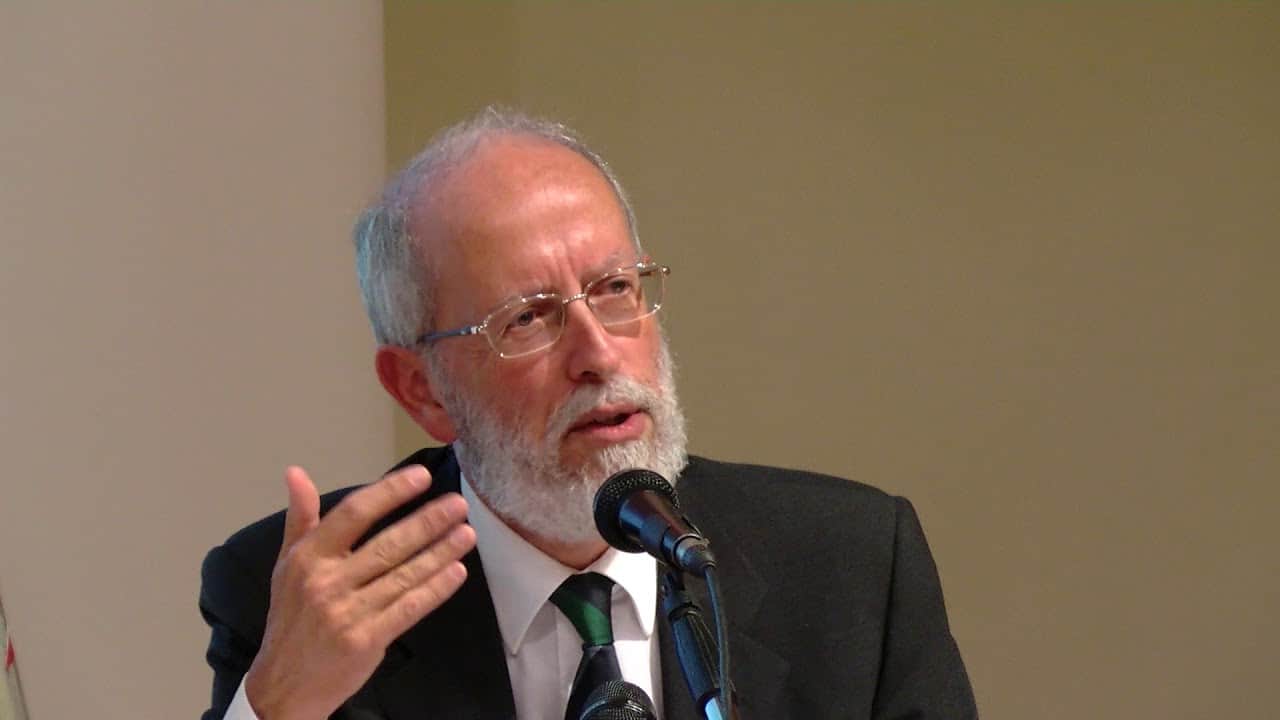

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.