La giustizia in prima pagina (e in prima visione) secondo Edmondo Bruti Liberati
Recensione a Edmondo Bruti Liberati, “Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione”, Raffaello Cortina Editore, 2022
di Andrea Apollonio
Un libro necessario alla magistratura di oggi che guarda con spirito critico alla magistratura di ieri, che non sempre si è trovata pronta a raccogliere le sfide della modernità; e la vera sfida della modernità giuridica è, oggi, il difficile equilibrio valoriale tra queste istanze: protagonista - anche suo malgrado - della società dell'informazione, la magistratura non si può ritrarre troppo e non si può esporre troppo, tenendo conto che - anche loro malgrado - giudici e pubblici ministeri sono osservati, scrutati e in ultimo giudicati - senza grado d'appello - dai cittadini.
Il 16 febbraio 2022 è una data da segnare sul calendario. Non solo perché la Corte Costituzionale ha posto - a fondamento delle pronunce di inammissibilità su tre quesiti referendari - alcuni principi ordinamentali non negoziabili, non soggetti al vaglio elettorale, innovando per questa via, ed in senso evolutivo, i dettami della Carta; ma anche in virtù del fatto che, all'esito di una lunga camera di consiglio, il presidente della Consulta ha estemporaneamente indetto una conferenza stampa per "spiegare" le ragioni di quei verdetti, dei "sì" e dei "no", non mancando neppure di rispondere a tono ad alcuni protagonisti della politica promotori dei referendum. In più di un passaggio il presidente Amato ha richiamato i suoi doveri di trasparenza nei confronti dei cittadini: è quindi a loro che dovevano essere spiegate le ragioni dell'ammissibilità o dell'inammissibilità dei quesiti referendari. Un "dovere" di spiegare le proprie decisioni che pure non era mai stato esercitato (almeno in maniera tanto diretta) dai suoi predecessori.
Questo è senza dubbio il capitolo mancante, e davvero conclusivo, del libro - uscito il 17 febbraio: incredibile a dirsi, il giorno dopo la rivoluzionaria conferenza stampa di Amato - di Edmondo Bruti Liberati, "Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell' informazione" (Raffaello Cortina, 2022), in cui non a caso si dà atto che "Le innovazioni più significative nella comunicazione istituzionale in Italia sono state adottate recentemente dalla Corte Costituzionale. [...] Nel complesso la comunicazione della Corte Costituzionale si presenta come un modello di servizio, accountability, conoscenza e comprensione"; ma, in effetti, neppure un autore così attento all'andamento dei tempi poteva immaginare un simile e repentino stravolgimento sul piano della comunicazione istituzionale della giustizia.
Perché in fondo di questo tratta il libro di Bruti Liberati: del modo in cui la giustizia nel corso degli anni, dei decenni e dell'ultimo secolo e mezzo, si è mostrata agli occhi del cittadino. E' quindi anzitutto una storia, raccontata dal più qualificato tra gli studiosi della materia, non solo per avere qualche anno addietro pubblicato una completa "Magistratura e società nell'Italia repubblicana" (una storia della magistratura italiana di cui questo libro si pone quale naturale prosecuzione, di un discorso mai interrotto), ma soprattutto per l'essere stato, nell'ordine, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, concludendo la propria carriera al vertice del più importante (e mediaticamente esposto) ufficio inquirente italiano: la Procura di Milano, dal 2010 al 2015. Anni, peraltro, di particolare e intensa dialettica, tra magistratura e politica.
La storia dello spinoso rapporto tra società, cittadino e voyeur da un lato, e giustizia dall'altro, è plasticamente resa già dalle prime battute del volume, che coincidono con i primi vagiti dello stato liberale: nel 1872 comincia a pubblicarsi a Milano la "Rivista dei dibattimenti celebri", poi divenuta "Giornale dei Tribunali", in cui si lascia ampio spazio alla cronaca dei giudizi in Corte d'Assise. Il delitto comincia a prendersi non solo le prime pagine, ma interi periodici, in un complessivo disegno sociale che vede il passaggio dalle procedure segrete e inquisitorie (di stampo illiberale) a quelle non solo pubbliche, ma pubblicizzate e ampiamente spettacolarizzate, accolto con favore dai più: secondo il penalista Francesco Carrara, è proprio "ad essi che spetta la civile missione di completare le nuove conquiste delle civili libertà".
Ma fin dalle prime battute del volume si dà conto anche delle evidenti distorsioni di quella primigenia forma di circo mediatico-giudiziario, tanto che già ne 1879 il Ministro della Giustizia ritenne di intervenire con una circolare per frenare quegli eccessi: "La pubblicità dei giudizi penali è una preziosa conquista della civiltà moderna, cui nessuno vorrebbe menomare. L'azione della magistratura deve potersi conoscere da tutti i cittadini, a tutela dei quali è diretta. Ma sarebbe uno strano equivoco il confondere la pubblicità con lo spettacolo. La giustizia si rende per soddisfare al primo dei bisogni sociali, non per appagare la curiosità degli oziosi". E' poi significativo che nella stessa circolare veniva svolto un richiamo al principio di innocenza, oggetto - nei medesimi termini - di una legge emanata appena qualche mese fa (nel 2021, e un secolo e mezzo dopo quella circolare...): "L'accusato, fino a che condannato non sia, si presume innocente; è un cittadino infelice di cui non è lecito aggravare le condizioni, degradandolo a figura da scena". Il primo messaggio che Bruti Liberati lancia dalle pagine del suo libro è quello di non lasciarsi stupire della ciclica riproposizione (strumentale e non) dei "problemi" della giustizia, con conseguenti proposte di riforme legislative (strumentali e non): tutti i temi erano in auge fin dai primi incerti passi dello stato liberale, e certo non solo la spettacolarizzazione dei processi, ma anche quelli connessi e annessi: "il processo parallelo, le fughe di notizie, la "gogna mediatica", il sondaggio tra il pubblico dei lettori, il protagonismo dei magistrati e degli avvocati, le campagne e le strumentalizzazioni politiche, la diffusione delle corrispondenze intime e private".
Con quest'andamento si attraversa dunque il fascismo e l'Italia repubblicana dei primi anni, in cui non senza sorpresa ritroviamo un "Corriere della Sera" molto attivo nelle vicende di nera e molto spinto su quello che oggi si sarebbe definito il fronte del "giustizialismo", con un poco conosciuto Dino Buzzati autore salace di pesanti contributi di cronaca giudiziaria - a quanto pare, quella la stagione in cui si cominciarono a dare nomignoli a indagati e imputati, quali "il mostro", "la belva" e via così. Con lo sguardo in ogni caso rivolto altrove per cogliere spunti di comparazione: oltralpe, nella civilissima Francia (tra i primi paesi ad introdurre il divieto di ritrarre indagati o imputati ammanettati o ingabbiati), e nei meno civili Stati Uniti, ove è ancora largamente in uso la perp walk, la macabra sfilata della persona arrestata e ammanettata dalla polizia "data in pasto al pubblico prima ancora di essere presentata davanti al giudice".
Un andamento narrativo che infine impatta nello strumento che più di ogni altro ha rivoluzionato il racconto della giustizia: la televisione. I due capitoli centrali del libro sono anche quelli tra loro speculari: "La televisione nel processo" e "Il processo nella televisione": perchè se è vero che, come ribadisce il giornalista francese Toussaint, "con la televisione bisogna convivere"; "[con la televisione] l'approccio al giudiziario sarà più brutale, ma, dopo tutto, meno ipocrita", questo potente apparecchio audio visivo è, proprio come i giornali dei e sui processi dello stato liberale, uno strumento da governare, per evitare il rischio di una ancor più accentuata spettacolarizzazione. Lo strumento è il più invasivo di tutti e - paradossalmente - il più democratico di tutti: al punto da potersi sostituire ai tribunali: "e quando la tv si sostituisce ai tribunali, questa è pura barbarie", scriveva Aldo Grasso, non trent'anni fa ma l'anno scorso.
A proposito di trent'anni fa. Certo, sono doverosamente richiamati tutti i principali casi giudiziari in cui la televisione fa ingresso nelle aule di giustizia, dagli anni sessanta ad oggi, ma il vero banco di prova di questa strana forma di pubblicità delle udienze rimane il processo Cusani (apice mediatico di Tangentopoli), che vedrà sfilare tutta la classe politica del tempo; sulla gestione dei media nell'ambito di quell'esperienza, il giudizio dell'autore sembra essere adesivo a quello espresso da Giorgio Bocca secondo cui le riprese televisive dei processi, è vero, generano divisioni nell' opinione pubblica, tra innocentisti e colpevolisti, persino rischiano di influenzare il processo: ma si tratta di un "male minore di fronte ai tribunali speciali, segreti". Ma c'è il solito bilanciamento da effettuare, perché è chiaro che "i media tendono a ricostruire i dibattiti giudiziari in un racconto più fluido, talora stereotipato, attento agli accadimenti più spettacolari capaci di suscitare e mantenere l'interesse pubblico". C'è il solito "strano equivoco" in cui si rischia di cadere: il confondere la pubblicità con lo spettacolo.
E non può mancare, sul fronte del "processo in televisione", la fenomenologia di alcune trasmissioni televisive, dall'esordio di "Un giorno in pretura", apparso sugli schermi nel 1983, fino ad arrivare alla più recente trasmissione "Quarto grado", senza saltare - s'intende - il celebre plastico della villetta di Cogne di "Porta a porta" né il meta-processo di "Storie maledette". Non mancano certo gli spunti di riflessione, mentre la conclusione è impietosa: lo strumento televisivo, che era da governare nell'ambito dei principi democratici di trasparenza e corretta informazione, è invece sfuggito di mano, oppure finito nelle mani sbagliate, come comprova l'imbarazzante caso dei "calzini" di un giudice milanese, attenzionato da alcuni media sol perché autore di una sentenza resa in una controversia civile collegata al cosiddetto "Lodo Mondadori".
Ampio spazio è anche dedicato, in termini maggiormente tecnici, alla normativa che, con scarsi risultati, si prefigge lo scopo di regolare i rapporti tra giustizia e media: da un lato, il segreto degli atti di indagine e il divieto di pubblicazione (nei codici), le stringenti regole per la comunicazione delle Procure (nell'ordinamento giudiziario), il recepimento della direttiva sulla presunzione di innocenza (nella normativa di settore); dall'altro lato continua però ad essere pressante il dovere di comunicare l'esercizio della giustizia, perché - considerata l'indubbia rilevanza pubblica di alcuni atti di indagine, con riferimento a taluni soggetti o a taluni fenomeni criminali - "il problema non è se, ma come la procura deve comunicare nella fase coperta dal segreto investigativo": e qui l'autore sente di dover puntare il dito contro quei pochi ma significativi casi di informazione autorefenziale e protagonistica, analiticamente illustrati, che riempiono le prime pagine (e le prime visioni) a discapito delle tante buone prassi che si registrano nella gran parte degli uffici giudiziari italiani.
Si percepisce che il libro di Bruti Liberati è stato ragionato nel tempo e realizzato in corso d'opera: quasi una sintesi di elaborazione e pensiero di uno dei protagonisti della magistratura italiana (tale è ancora oggi: anche dismessa la toga non ha mai fatto mancare la propria voce nel dibattito pubblico sui temi della giustizia). Tra le cui righe si ravvisano in particolare due punti fermi: la condanna di ogni forma di protagonismo dei (pochi) magistrati sui media (soprattutto pubblici ministeri), spesso sinonimo di "esibizionismo, supponenza e settarismo", che genera effetti distorsivi a cascata tali da "vanificare la "buona" comunicazione dei magistrati"; e, appunto, il "dovere" di comunicare la giustizia, perché "la trasparenza richiesta nelle società democratiche esige la comunicazione istituzionale sulla giustizia" - un principio che il presidente della Corte Costituzionale ha da ultimo reso concretamente fruibile ai cittadini. Senza dimenticare, però, che il diritto di espressione del magistrato, la sua libertà di pensiero, se ben esercitata, può essere una risorsa per la democrazia: si rivela prezioso il contributo che "i magistrati possono dare al confronto che si svolge nella società sui temi della giustizia in quanto esperti di diritto, ma anche sulla base della loro esperienza nel rendere giustizia".
Un libro necessario alla magistratura di oggi che guarda con spirito critico alla magistratura di ieri, che non sempre si è trovata pronta a raccogliere le sfide della modernità; e la vera sfida della modernità giuridica è, oggi, il difficile equilibrio valoriale tra queste istanze: protagonista - anche suo malgrado - della società dell'informazione, la magistratura non si può ritrarre troppo e non si può esporre troppo, tenendo conto che - anche loro malgrado - giudici e pubblici ministeri sono osservati, scrutati e in ultimo giudicati - senza grado d'appello - dai cittadini. E' la conclusione a cui naturalmente si perviene, ed a cui naturalmente perviene Bruti Liberati: "tanto più oggi è necessario che l'opinione pubblica, informata attraverso il "quarto potere", possa esercitare il suo controllo critico sul "terzo potere". E gli ultimi tre lunghi, tempestosi anni, ce lo hanno ampiamente dimostrato.

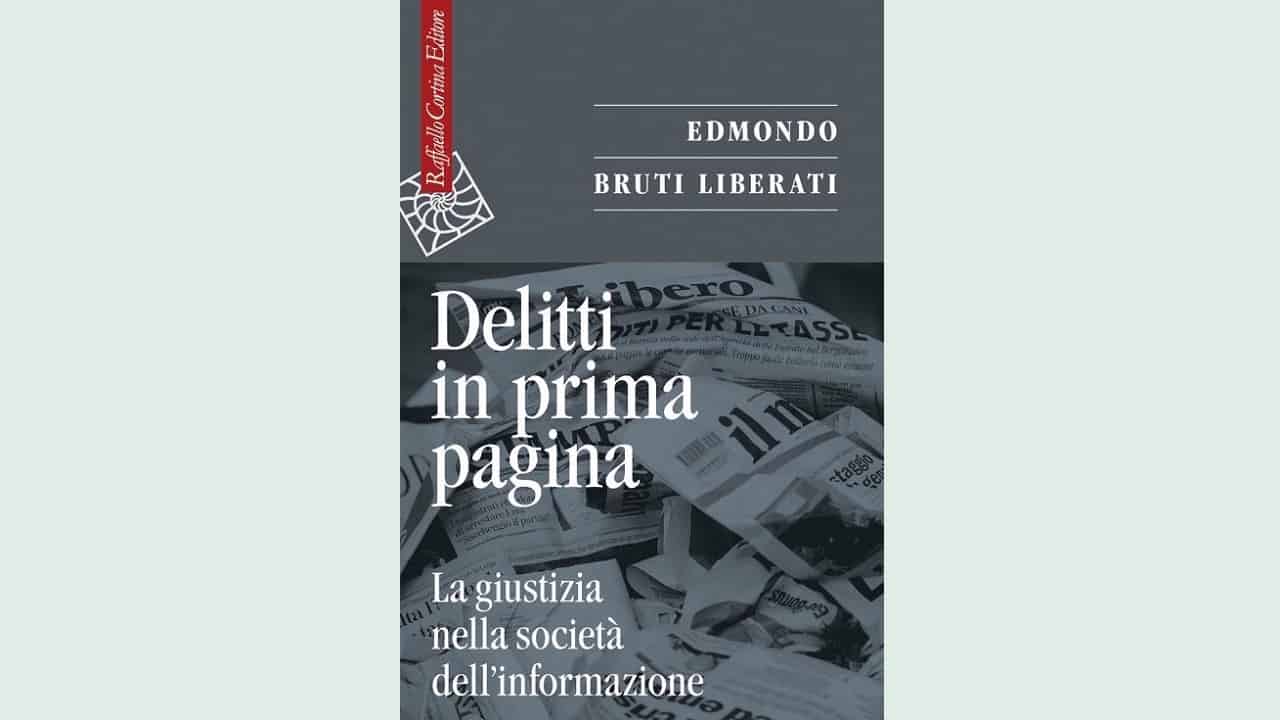

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.