Il Referendum per l’eutanasia legale. Forum di Giustizia Insieme. 5) Giuseppe Cricenti
Intervista di Roberto Conti a Giuseppe Cricenti
1. La via referendaria in tema di eutanasia dopo le decisioni della Corte costituzionale sul caso Antoniani-Cappato - sentenza n. 242/2019 e ord. n. 207/2018 -. Indebita interferenza rispetto al possibile intervento legislativo ovvero uso legittimo dello strumento referendario per dare attuazione alle pronunzie della Consulta?
Mi preme una premessa. Se si parla di eutanasia, e se il referendum mira a renderla lecita, allora serve chiarire di cosa si tratta: per una ormai più che decennale riflessione, l’eutanasia si distingue sia dall’omicidio del consenziente che dal suicidio assistito.
Se fosse stato chiaro questo assunto, ormai recepito da buona parte della filosofia bioetica, probabilmente anche la decisione della Corte Costituzionale sarebbe stata diversa.
In bioetica, come in filosofia morale, è eutanasia l’interruzione- attiva o passiva che sia- di una cura vitale, e dunque è una situazione che presuppone un paziente affetto da una malattia mortale, o irreversibile, che è tenuto in vita – o potrebbe esserlo- da una qualche terapia medica, e che chiede che la malattia faccia il suo corso, ossia che rifiuta una cura che potrebbe prolungare la sua esistenza o renderla temporaneamente migliore.
Il fatto che l’intervento medico si attui su un essere già nato, serve poi a distinguere l’eutanasia dall’aborto.
Questa è la definizione di eutanasia che a partire dalla riflessione di Beauchamp e Davidson, nel 1979, è pressoché diffusa in bioetica, e che in gran parte è stata trascurata dalla Corte Costituzionale nel 2019.
Giova riassumerla sinteticamente.
Secondo questa definizione la morte di un essere umano, A, è un caso di eutanasia se e solamente se: (i) la morte di A è provocata da un altro essere umano, B, ma nel senso che quest’ultimo può essere sia la causa della morte di A che un elemento causalmente pertinente dell’evento morte (che ciò avvenga dunque per azione od omissione non rileva); (ii) B dispone di sufficienti elementi per credere che A soffre in modo intenso o è in uno stato di coma irreversibile, e questa credenza si fonda su una o più leggi causali attestate; (iii) la ragione maggiore per cui B vuole la morte di A è nel far cessare le sue sofferenze; (iv) tre le procedure che consentono la morte di A, A e B scelgono quelle che producono le minori sofferenze ad A, e comunque sofferenze minori di quelle che con la morte si vorrebbero far evitare; (v) A non è un organismo fetale.
Si tratta di cinque condizioni, individualmente necessarie ed insieme sufficienti a definire l’eutanasia.
Intanto (i) deve trattarsi di morte provocata da un terzo, condizione che serve a distinguere l’eutanasia dal suicidio; deve essere voluta per porre fine alle sofferenze di una malattia mortale irreversibile (ii e iii), e dunque, come abbiamo visto non può parlarsi di eutanasia rispetto ad un soggetto sano, né può questa condizione servire a distinguere tra azioni ed omissioni, ipotizzando che solo in quest’ultimo caso la morte sopravviene per decorso naturale della malattia, e salva la restrizione del concetto alle sole sofferenze dovute a malattie mortali o terminali, o particolarmente gravi, e si spiega perché (iv) la sofferenza provocata dalla procedura di eutanasia prescelta non deve produrre sofferenze maggiori di quelle che si vogliono evitare. L’ultima clausola (v) consente di distinguere l’eutanasia dall’aborto; le prime quattro da qualsiasi forma di omicidio o suicidio assistito.
È una concettualizzazione, questa, in base alla quale è possibile identificare la condotta di eutanasia come autonoma, e distinguerla da altre condotte caratterizzate dall’evento morte, provocato da un terzo (omicidio, suicidio assistito, aborto ed altro).
Ricordo infatti che la Corte ha ritenuto non punibile il suicidio assistito quando è praticato verso un paziente affetto da malattia terminale e che chiede di porre fine alle proprie sofferenze: non già un qualsiasi aiuto a porre fine alla propria esistenza.
Ciò che la Corte non si è spinta a dire è che, a tal fine, non conta la distinzione tra eutanasia attiva e passiva, e si è cosi limitata a considerare il caso di eutanasia passiva come una ipotesi, lecita o non punibile , di suicidio assistito, facendo rientrare invece quello di eutanasia attiva nella ipotesi di omicidio del consenziente, dunque punibile.
Da qui il referendum, ed il suo oggetto.
2. La circostanza che, rispetto alle decisioni della Corte costituzionale ricordate nel primo quesito, il quesito referendario intenda incidere sull’art. 579 c.p. e non sull’art. 580 c.p., direttamente interessato dalla pronunzia di parziale incostituzionalità, assume qualche rilievo ai fini dell’ammissibilità della proposta?
L’intervento della Corte Costituzionale pone una chiara delimitazione: l’assistenza fornita dal medico- o chi per lui- è lecita se è rivolta ad un malato affetto da patologia irreversibile, tenuto in vita da un intervento sanitario salvifico.
Questa delimitazione ha qualcosa di ovvio, che viene sottovalutato: il paziente, affetto da una qualche malattia, su cui ancora non è intervenuta alcun trattamento medico, è oggi, come lo era in passato, libero di rifiutare quell’intervento. Nessuno può dubitare che anche prima della decisione della Corte Costituzionale, se avessero detto ad un paziente “o ti fai amputare un arto o muori”, costui avrebbe ben potuto rifiutare l’intervento e nessuno avrebbe potuto costringerlo, e ciò senza ipotizzare reati a carico del medico che avesse rispettato tale volontà.
Il problema si è dunque sempre posto per i casi in cui il rifiuto interviene a trattamento medico iniziato, che sono quelli che pongono problemi di liceità dell’intervento medico; l’eutanasia è nient’altro che questo: l’interruzione di una cura salvifica o di mantenimento su un paziente irreversibilmente malato.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto che solo quella che impropriamente si chiama eutanasia passiva rientra tra i casi di suicidio assistito, precisando che si tratta di una ipotesi non punibile, per le ragioni che sappiamo.
Invece, come meglio vedremo, ha ritenuto che l’eutanasia cosiddetta attiva è un caso di omicidio del consenziente, con la conseguenza paradossale che, depenalizzata l’eutanasia passiva, quella attiva è da considerarsi punibile proprio in ragione dell’articolo 579 c.p.
3. A suo avviso il quesito tende ad integrare il quadro normativo vigente piuttosto che ad abrogare una disposizione già colpita dalla pronunzia di parziale incostituzionalità, ovvero esso si pone nell’ambito della piena ortodossia degli interventi referendari ammessi dalla Costituzione?
V’è da fare una premessa ulteriore. Dalla decisione della Corte Costituzionale, che in questo ha tenuto conto di un confuso parere del Comitato di Bioetica, sembra derivare che l’eutanasia, in senso stretto, è quella passiva, ossia mera interruzione della cura; mentre quella che, in una certa tradizione di pensiero si identifica come eutanasia attiva, rientrerebbe nell’omicidio del consenziente e non sarebbe quindi lecita.
Non ho qui lo spazio per spiegare perché questa sia una distinzione irrilevante: come se vi fosse qualcosa di diverso tra la condotta del medico che procura la morte ad un paziente con una iniezione, anziché interrompendo il trattamento che lo mantiene in vita.
Non ci sono mai stati argomenti irresistibili a presidio di quella distinzione (rimando chi volesse approfondire a CRICENTI, Il sé e l’altro. Bioetica del diritto civile, Pisa, 2013, p. 89 e ss.).
Tuttavia, una tale distinzione dalla decisione della Corte emerge, ed autorizza a pensare che solo l’eutanasia passiva è lecita, ossia è un caso di suicidio assistito non punibile, mentre quella attiva rientra tra le ipotesi di omicidio del consenziente.
Ed infatti, la Corte precisa che la legge vigente- il riferimento è alla 219 del 2017- consente al paziente di rifiutare una cura ma non consente al medico una condotta attiva che causi la morte del malato e neanche una condotta con cui il medico metta a disposizione del paziente mezzi utili a procurarsela da sé.
Il Comitato di Bioetica aveva esemplificato questa conclusione dicendo che un conto è che il caso del medico che consegna un farmaco letale al paziente e costui lo assume da sé, altro quello in cui che glielo somministra direttamente (p. 9 del parere).
Senza bisogno di interrogare gli esperti -di logica, oltre che di bioetica e diritto- ognuno intende la speciosità e la irrilevanza di tale distinzione.
Ma se proprio si cercano risposte dotte a quella strana idea del Comitato di Bioetica, stanno nelle critiche che i neokantiani rivolgono alla teoria dell’azione come fatto materiale propria di J.S. MILL (ad esempio O. O’NEILL, Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge, 2002).
Tuttavia, è un dato di fatto che, allo stato dell’arte, l’eutanasia attiva non rientra tra i casi leciti e rischia di ricadere nella fattispecie dell’omicidio del consenziente, a seguire la tesi della Corte Costituzionale.
Da questo punto di vista il referendum correttamente è indirizzato verso l’articolo 579 c.p., ma rischia di produrre effetti maggiori di quelli semplicemente limitati alla depenalizzazione della eutanasia attiva.
4. Esiste, a Suo avviso, il pericolo che il quesito referendario formulato dai proponenti, se accolto, consenta la depenalizzazione del reato di aiuto al suicidio anche al di fuori dei limiti fissati dalla Corte all’incostituzionalità dell’art. 580 c.p., al punto da escludere l’antigiuridicità dell’uccisione per effetto del mero consenso della persona che chiede di interrompere la propria esistenza? Ove Lei ritenesse sussistente tale pericolo, lo stesso potrebbe essere eventualmente considerato in sede di ammissibilità del quesito da parte della Corte costituzionale?
Le carenze del referendum, come si è detto, discendono dalla situazione sopra evidenziata: se si ha di mira di correggere gli esiti della pronuncia della Corte e dunque includere nella depenalizzazione anche l’eutanasia attiva- che, si ripete, secondo la decisione della Corte non sarebbe lecita e costituirebbe omicidio del consenziente- allora occorre specificarlo.
Invece, il quesito mira più genericamente a depenalizzare casi di intervento di terzi sulla vita altrui che non sono definibili né come eutanasia attiva né passiva, ossia non sono per niente casi di eutanasia, la quale, si ripete al di là della modalità con cui è praticata- attiva o passiva- presuppone pur sempre l’intervento del medico o di un terzo in generale sulla vita di un paziente irreversibilmente sofferente se non terminale.
Allora il quesito solleva dubbi, se mira ad ampliare i casi di eutanasia, ossia se si vuole dare di questa pratica una definizione più ampia: per me si tratta di casi che esulano dal concetto di eutanasia, e che dovrebbero avere un trattamento diverso: altro è il paziente irreversibilmente malato, che non intende più soffrire e che chiede che la malattia faccia il suo corso; altro chi vuol porre fine alla sua vita per depressione o altro.
È chiaro che l’esito del referendum, essendo quello di confinare i casi di omicidio del consenziente, alle ipotesi in cui il soggetto passivo è minore, o incapace, o soggetto a violenza, rende leciti tutti gli altri, dunque anche l’ “omicidio” del depresso, che però, piaccia o no, non è eutanasia.
5. Vi sono, a Suo giudizio, carenze del quesito referendario rispetto alle questioni poste dalla sentenza n. 242/2019?
Come ho detto, il quesito è imposto dagli esiti di quella sentenza, ma va oltre. Comporterà la depenalizzazione non solo dell’eutanasia in senso stretto, ma anche di aiuti a morire verso soggetti che non sono malati di un morbo mortale o che non soffrono in modo inaccettabile: penso, ad esempio, all’ “eutanasia” dei depressi.
6. Quali effetti potrà determinare la decisione in punto di ammissibilità del quesito referendario sull’iter parlamentare che riguarda la proposta di legge sul suicidio assistito?
Gli esiti del referendum, cosi posto, saranno di ampliare come si è detto la liceità dell’intervento medico – e non solo medico- sulla vita altrui, meglio, sulla interruzione della vita altrui. E mi pare evidente che se non si precisa che da depenalizzare è solo l’eutanasia come l’abbiano definita prima, si renderanno lecite una serie di condotte che invece sarebbe meglio vietare.
Io penso che nessuna società può ancora permettersi una medicalizzazione del suicidio: se un depresso, o una persona che comunque ha ragioni per voler morire, che non sono costituite da una malattia mortale, può accedere ad una “prestazione medica” per realizzare questo desiderio, non abbiamo legalizzato l’eutanasia, ma medicalizzato il suicidio.
Ciascuno può pensare che non vi sarebbe niente di male, ma dovrà ammettere che lungi dal costituire, questo passo, un progresso dell’autonomia del paziente – e resta evidente che ne beneficeranno anche i non pazienti- è al contrario un regresso: torna il ruolo della medicina come accertamento della “verità del fatto patologico” e quello che è un gesto privato – il suicidio- viene affidato nuovamente al medico.
Non mi scandalizzerei se vi fosse dunque un intervento correttivo del Parlamento, a precisare gli ambiti della legalizzazione della eutanasia nei termini che abbiamo visto.
Del resto, sono tra coloro che pensano che certe questioni non vanno affidate solo ai giudici e che un legge di bioetica, sul modello francese, ossia revisionabile ogni dato numero di anni, è la forma migliore per affrontare questi problemi.

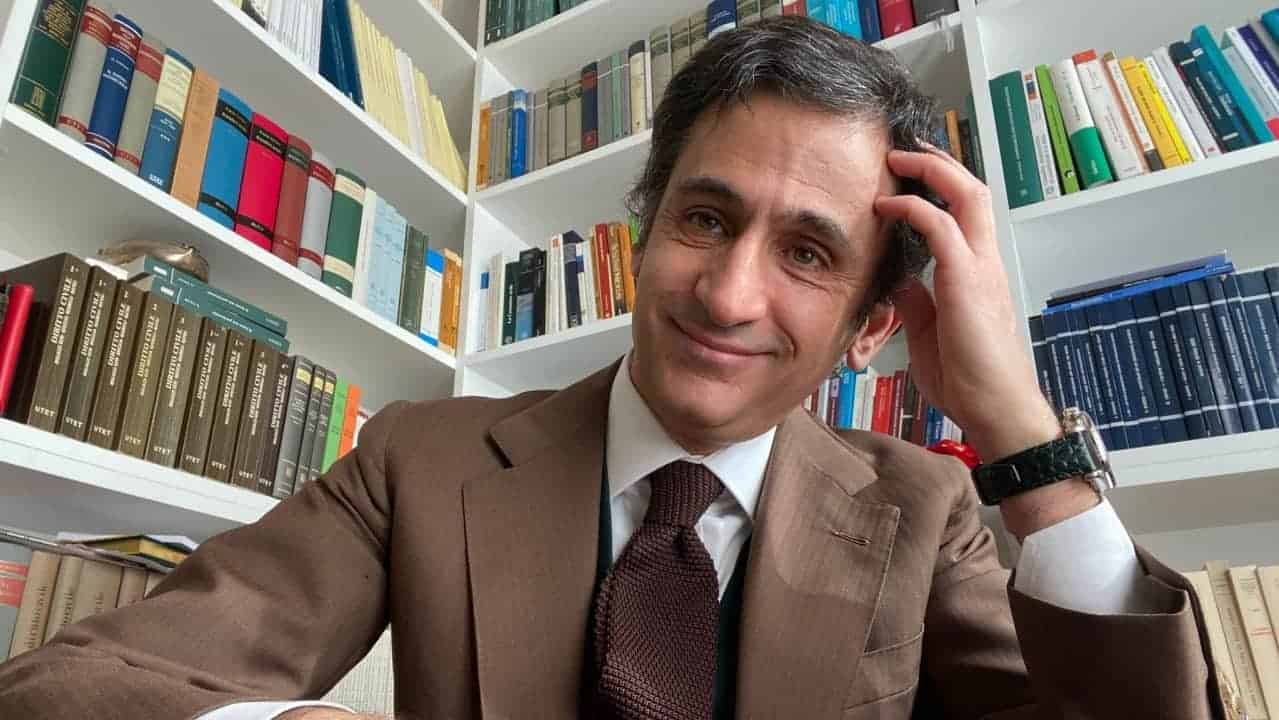

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.