Dallo svolgimento del processo alle ragioni della decisione: appunti sulla scrittura delle decisioni di Franco Petrolati
Sommario: 1. Il tempo del giudizio - 2. La lettura del giudizio: le sentenze della Corte Costituzionale - 3.Ordinanze e participi.
1.Il tempo del giudizio
Sono trascorsi oltre dieci anni da quando la legge 18 giugno 2009, n. 69, a partire dal 4 luglio 2009, sostituì l’art. 132, II c., n. 4, c.p.c. eliminando tra i requisiti di forma-contenuto delle sentenze civili la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e così limitando il requisito propriamente motivazionale alla esposizione, comunque concisa, “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tale novella è stata per lo più interpretata come una mera semplificazione in senso riduttivo – una sorta di dimagrimento - della struttura della sentenza civile, così trascurandone, invero, l’impatto sulle modalità stesse di formulazione della motivazione.
E’ infatti da evidenziare il rilievo assegnato alla essenziale connotazione della sentenza in termini di giudizio (“le ragioni”) piuttosto che di narrazione/rievocazione di fatti, con conseguente emarginazione dei contenuti storici della vicenda sostanziale e processuale.
Nell’orbita propria del giudizio i fatti non sono certamente da trascurare ma sono piuttosto da rappresentare esclusivamente nella loro dimensione di ragioni di fatto, vale a dire nella sola consistenza funzionale alle considerazioni in diritto che se ne traggono, in quanto proprio da tale rappresentazione dei fatti derivano le consuete operazioni inerenti alla sussunzione nella fattispecie astratta e, soprattutto, all’individuazione degli effetti che si spiegano nel caso concreto.
Gli eventi sono, in tal senso, nuovamente rappresentati affinchè sia disposto alcunchè in ordine alla loro ideale prosecuzione nella concreta vicenda sostanziale o processuale: così all’accertamento di un fatto illecito consegue la sanzione restauratrice del corso degli eventi, in forma specifica o per equivalente; alla dichiarazione di nullità dell’atto processuale le conseguenti rinnovazioni ex art. 162 c.p.c..
Si dovrebbe, pertanto, adottare nei verbi un tempo adeguato a rappresentare gli eventi nel loro svolgersi per cogliere la continuità tra tali accadimenti e gli effetti che ne derivano all’attualità e che si protendono nel tempo successivo, in quel divenire tra passato, presente e futuro che contrassegna propriamente l’esercizio della giurisdizione.
Di qui l’incongruità dell’uso dei tempi passati, i quali emarginano il fatto in un contesto già esaurito e segnano una netta cesura rispetto all’attualità della narrazione; è piuttosto da apprezzare l’uso del tempo presente con riguardo non solo alle considerazioni in diritto ma anche a quelle propriamente in fatto, pur se gli accadimenti risalgono a molti anni indietro rispetto all’epoca della decisione: Tizio stipula il contratto nel 1985, si avvale nel 1996 della clausola risolutiva, chiede oggi la condanna ecc..
La formulazione dei fatti al tempo presente (c.d. presente storico) determina indubbiamente un apparente appiattimento degli eventi pur succedutisi a notevole distanza temporale: si tratta, tuttavia, di un livellamento connaturale alla giurisdizione, laddove gli eventi rilevano solo come elementi di fattispecie tutti da rappresentare contestualmente ai fini della formulazione della regola finale del caso concreto.
Il giudice è, infatti, chiamato ad una operazione essenzialmente logica utilizzando le risultanze processuali ed parametri normativi ed è, quindi, affatto congruo che i fatti - sub specie di ragioni di fatto - siano tutti esposti nel medesimo tempo pur nella diversa – ed eventualmente precisata – collocazione diacronica.
L’effetto drammatico – rievocativo resta, invero, integro - così come avviene con il tradizionale uso dell’imperfetto : Tizio stipulava ….non corrispondeva ecc. - in quanto l’autore continua a porre se stesso ed il suo ideale lettore sullo stesso piano degli eventi narrati, colti nel momento in cui accadono; ma è, altresì, evidenziato, con il tempo presente, che gli eventi rilevano all’attualità come elementi di un giudizio e non nella loro dimensione propriamente storica.
In tal senso il tempo proprio della sentenza diventa il tempo presente quale tempo del giudizio, vale a dire del momento di formulazione delle ragioni di fatto e di diritto in cui si articola la motivazione.
2.La lettura del giudizio: le sentenze della Corte Costituzionale
Ogni motivazione è destinata ad essere ovviamente letta: non rileva cioè nella sua mera obiettività, come compiuta e tecnicamente esatta esposizione delle ragioni, ma anche nella idoneità ad essere congruamente percepita.
In tal senso si può riscontrare che l’uso del tempo presente agevoli senz’altro non solo l’esposizione ma anche la comprensione dei fatti rappresentati.
Tuttavia l’attenzione al destinatario della motivazione – che non è solo il difensore o la parte ma potenzialmente l’intera comunità – deve indurre ad una più profonda semplificazione della formulazione del giudizio, quanto meno nel senso di attenuare, per quanto possibile, lo sforzo richiesto per la sua percezione.
Potrebbe così essere giustificata una minore compiutezza o precisione nel richiamo ad un fatto – magari già in precedenza circostanziato - allorchè si tratta formulare propriamente solo un giudizio sullo stesso.
Al riguardo è forse utile aprire il sipario anche sulle sentenze della Corte Costituzionale - nella sua veste di giudice delle leggi - le quali appaiono, invero, conformate ad un modello formale tutto imperniato sulla compiutezza della esposizione piuttosto che sulla leggibilità e, quindi, sulla fruizione della motivazione.
Sono, infatti, strutturate in una prima parte, recante l’epigrafe “Ritenuto in fatto”, la quale corrisponde in realtà allo svolgimento del processo, ed in una seconda parte propriamente motiva, con l’epigrafe “Considerato in diritto”, nella quale vengono esposte le ragioni della decisione.
Tuttavia è da riscontrare che le considerazioni “in diritto” sono nuovamente precedute dalla compiuta riformulazione delle stesse questioni già esposte in precedenza “in fatto”, così sostanzialmente integrando autonomamente il requisito della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto proprie della sentenza civile ex art.132, II c., n. 4, c.p.c..; al punto che il lettore ben potrebbe limitarsi a tali “Considerazioni in diritto” per comprendere il contenuto della sentenza.
Il parametro normativo specifico per le sentenze della Consulta, l’art. 18, legge 11 marzo 1953, n. 87, si limita a disporre che siano indicati i “motivi di fatto e di diritto”, con formulazione che ben può leggersi come simmetrica, in via sistematica, con quella dettata per la sentenza civile, nel senso cioè che i “motivi” corrispondono alle “ragioni” ex art. 132 c.p.c..
E’ vero, poi, che avanti alla Corte Costituzionale i “fatti” di cui si controverte sono in realtà “le leggi”, tuttavia anche le leggi potrebbero essere richiamate solo in quanto funzionali ad un “giudizio” destinato ad essere essenzialmente “letto”; di qui la preferenza che dovrebbe essere accordata alla continuità della esposizione delle “ragioni” piuttosto che alla completezza degli elementi meramente descrittivi delle leggi.
In concreto è, ad esempio, da evitare che le leggi siano reiteratamente citate mediante l’indicazione dei rispettivi “titoli”, i quali aprono parentesi quasi sempre non utili alla formulazione delle “ragioni” e costringono continuamente il lettore ad operare mentalmente dei “salti” per non pregiudicare la continuità della percezione dell’argomentazione.
Analoghi rilievi potrebbero essere svolti quanto alla citazione delle reiterate modificazioni intervenute “medio tempore” rispetto alla formulazione originaria della disposizione di legge (“l’art. X della legge Y così come modificata dall’art. A della legge B ecc.”); tali citazioni possono, infatti, essere effettuate una sola volta nel corpo della motivazione ed eventualmente sostituite dal mero richiamo alla vigenza della disposizione in un dato contesto temporale (“l’art. X nella formulazione vigente alla data del….”).
Si tratta di rilievi apparentemente banali ma che proprio nella legislazione contemporanea finiscono per assumere rilievo in quanto fioriscono leggi dal contenuto disomogeneo, con titoli intenzionalmente ipertrofici, le quali si sovrappongono diacronicamente con intensa frequenza: di qui la opportunità di una citazione delle disposizioni di legge semplificata, per quanto possibile, per assicurare l’agevole leggibilità della motivazione, vale a dire la sua funzionalità oltre che la compiutezza strutturale.
3.Ordinanze e participi
A fronte della semplificazione operata nel 2009 nella struttura della sentenza è da rivedere anche l’originario assunto secondo cui l’ordinanza abbia un contenuto essenzialmente minore quanto alla motivazione: in effetti il parametro normativo non implica alcuna apprezzabile differenza in quanto l’ordinanza è “succintamente motivata” ex art. 134, I c., c.p.c. e la sentenza comprende, analogamente, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto” ex art.132, II c., n.4 c.p.c..
La tradizionale articolazione delle ordinanza in capoversi preceduti da participi (“Rilevato che”, “Ritenuto che” ecc.) non sembra, poi, corrispondere ad alcuna effettiva semplificazione in quanto un dato può essere rilevato od un giudizio può essere espresso anche senza la reiterazione di un participio passato come premessa: si può così argomentare che il cielo è azzurro anche senza preavvisare il lettore che si è “considerato che”.
Con ciò non si vuole affatto sminuire l’utilità di una articolazione della motivazione, in sentenza come in una ordinanza, per punti e paragrafi, segnalati anche da opportuni simboli numerici o grafici; tuttavia l’incipit reiterato con i participi passati sembra, oltre che inutile, il retaggio di un esercizio della giurisdizione, dall’alto di una sovrana intelligenza, certamente non più consona alla attuale dialettica processuale imperniata sulla parità delle parti.

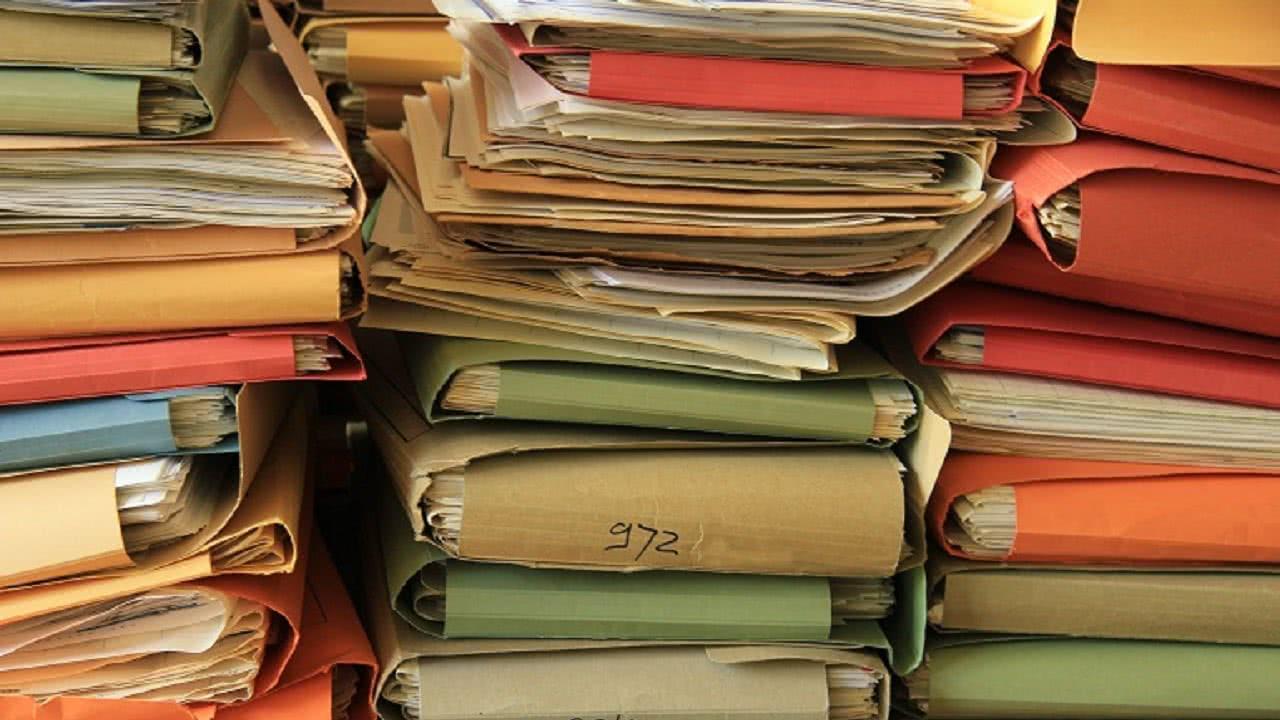

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.