La dirigenza giudiziaria tra realtà e futuro. 1. La “carriera” in magistratura. Problemi aperti, soluzioni apparenti e soluzioni possibili
di Edmondo Bruti Liberati
Sommario: 1. L’abbattimento della carriera. - 2. Il “sistema tabellare”. - 3. Il Csm e le “promozioni” dei magistrati. - 4. Le “non soluzioni” dei problemi. - 5. Alcune “modeste proposte”. - 6. La ineludibile discrezionalità del Csm. - 7. Ultimo.
1. L’abbattimento della carriera
La disposizione dell’art. 107, co. 3, Cost. “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni” delinea un modello antitetico rispetto a quello dell’ordinamento Grandi, sostanzialmente ricalcato sulla organizzazione giudiziaria napoleonica. Le resistenze all’attuazione della radicale riforma imposta dalla Costituzione sono fortissime.
Il sistema di carriera allora in vigore prevede che dopo il superamento del concorso e pochi mesi di tirocinio sul campo, la prima destinazione degli uditori sia decisa dal Ministero non sulla base di criteri prefissati, ma secondo le "esigenze di servizio", concetto alquanto permeabile alle pressioni clientelari. I due anni successivi sono una sorta di periodo di prova, destinato a concludersi con un nuovo esame per la nomina ad aggiunto giudiziario anch'esso con impostazione sostanzialmente teorica. Per prepararsi bene alla prova scritta è utile riuscire a farsi assegnare ad una grande sede, magari ad una sezione civile del tribunale, o in alternativa, ad una sede o funzione con scarso carico di lavoro, ove poter continuare a coltivare gli studi. Di qui la fuga dalle sedi difficili e dagli uffici di prima linea ed in generale dal settore penale.
Le successive nomine-promozioni a magistrato di Tribunale e a consigliere di Appello sono conferite, all’esito di un concorso per titoli, da una commissione giudicatrice composta esclusivamente da alti magistrati; sono decisivi l’esame dei provvedimenti giudiziari redatti ed i pareri dei capi. Può capitare di essere stati assegnati ad un ufficio o funzione in cui si sia avuta l’occasione di trattare casi involgenti delicate questioni di diritto e quindi di avere scritto dotte sentenze o brillanti requisitorie. Ma può anche capitare di essere stati assegnati a sedi difficili o periferiche, nelle quali non vi è occasione e tempo per scrivere “trattatelli giuridici”. Il potere di conformazione della gerarchia interna non trova contrappesi e d’altronde, non vigendo alcuna regola per la assegnazione degli affari, ai giudici troppo zelanti può essere sottratto ogni caso di rilievo.
Poiché lo stipendio è collegato alle funzioni effettivamente svolte, la regola aurea è quella di non porsi in contrasto con la gerarchia e di non attardarsi in uffici o funzioni di “prima linea” poco indicati per la redazione di provvedimenti brillanti, di non esplorare soluzioni giuridiche innovative e, men che meno, promuovere indagini scomode per esponenti del potere politico o economico.
Nessuno allora parla di "politicizzazione" della magistratura: il sistema di carriera è decisivo nell’assicurare una sintonia con il potere. In un’incisiva rievocazione del clima di quegli anni è stato scritto:
“influiva su tale sintonia il fatto che ogni magistrato in qualche modo dipendesse dal potere esecutivo quanto a carriera; i selettori erano alti magistrati col piede nella sfera ministeriale; tale struttura a piramide orientava il codice genetico; l' imprinting escludeva scelte, gesti, gusti ripugnanti alla biensèance filogovernativa; ed essendo una sciagura l'essere discriminati, come in ogni carriera burocratica, regnava l’impulso mimetico" [1].
Nell’arco di un decennio, tra il 1963 ed il 1973, il sistema di carriera è radicalmente modificato realizzandosi il distacco della categoria (grado) dalla funzione, con un sistema di progressione cosiddetta a ruoli aperti, che consente di conseguire la categoria e lo stipendio della funzione superiore pur continuando a svolgere le funzioni svolte in precedenza[2].
Il vecchio modello di carriera cade per la sua irrazionalità interna e senza l’affanno dell’avanzamento verso le funzioni “superiori” di appello e cassazione, magistrati con esperienza assicurano delicatissime funzioni di “prima linea” nelle preture, nelle procure e nei tribunali, come giudici e giudici istruttori.
Questa magistratura “senza carriera” affronterà le grandi riforme degli anni ’70 e poi criminalità organizzata, mafia, terrorismo e corruzione.
2. Il “sistema tabellare”
Nonostante la diversa opinione della Cassazione e le oscillazioni della Corte Costituzionale, il Csm, già a partire dalla fine degli anni '60, si era indirizzato verso una attuazione rigorosa del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co. 1, Cost.), riferendolo non solo all’organo giudiziario, ma anche alle persone fisiche dei giudici. La questione era stata posta sin dal 1963 da Gaetano Foschini con il celebre articolo Giudici in nome del popolo, non già commissari del capo della corte:
Impedire che un dato processo possa essere giudicato dal Tribunale di Catania invece che da quello di Ragusa non vale niente, se non resta impedito anche che si costituisca il tribunale di Ragusa applicando ad esso i giudici del tribunale di Catania[3].
Il Csm rivendica il suo sindacato sui provvedimenti di applicazione e supplenza e costruisce progressivamente il “sistema tabellare” con le circolari per la formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari ed i criteri di assegnazione degli affari. Tali circolari rappresentano uno dei più rilevanti esempi dell’attività “paranormativa” del Consiglio.
Per la prima volta in un testo di legge viene prevista la precostituzione del giudice, non solo come ufficio, ma anche come persona fisica, con un esplicito riferimento alla formazione delle tabelle da parte del Csm, con l’art. 25 della legge 6 agosto 1982 n. 532 istitutiva del Tribunale della libertà poi Tribunale del riesame
Il Parlamento dà riconoscimento al sistema tabellare: in questa materia si è istituito tra Csm e Parlamento un “circolo virtuoso”[4]. Ma prima ancora ha operato in modo “virtuoso” l’influenza delle “correnti” dell’Anm sul Csm. La limitazione del potere arbitrario dei capi degli uffici che nasce come richiesta “corporativa”, che peraltro si fonda sul principio dell’indipendenza interna, approda a rendere effettiva la garanzia del giudice naturale.
3. Il Csm e le “promozioni” dei magistrati
Tra le attribuzioni del Csm definite all’art. 105 della Costituzione vi sono le “promozioni” dei magistrati. Il costituente, ricorrendo alla locuzione “promozioni”, risente certamente del tradizionale assetto gerarchico che connotava la magistratura, ma chiaro è il riferimento ai dirigenti degli uffici, la cui nomina si vuole sottratta ad ogni ingerenza politica.
Una volta portata a conclusione la piena attuazione della indipendenza interna prescritta dall’art. 107, co. 3, con l’abbattimento della carriera e soprattutto con la piena attuazione del sistema tabellare, il ruolo dei dirigenti degli uffici giudiziari potrebbe sembrare destinato se non a scomparire almeno a divenire marginale. E di conseguenza drasticamente ridimensionato il ruolo di un Csm che selezionasse i dirigenti degli uffici secondo un rigido criterio di anzianità.
Sappiamo che non è andata così. La piena attuazione della indipendenza interna con il sistema tabellare è arrivata a compimento solo alla metà degli anni Ottanta del Novecento e l’influenza dei dirigenti sul merito dei provvedimenti dei giudici “in sottordine” ha continuato a lungo a pesare.
Per altro verso per gli uffici di Procura la disposizione dell’art. 107, co. 4, Cost. (“Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”) ha precluso la operatività di una rigida applicazione del sistema tabellare e ha consentito il permanere di un assetto, che pur non potendosi definire propriamente gerarchico, ha attribuito al procuratore rilevanti poteri direttivi e organizzativi.
La nomina degli incarichi direttivi (e semidirettivi), lo sappiamo, è stata e continua ad essere una delle attribuzioni più rilevanti, nel bene e nel male, del Csm e dunque tra le più controverse. Attribuzione rilevante nel male perché oggetto, non da oggi, di scontri di potere, di pratiche di scambio e di posizioni settarie delle componenti togate non meno che delle laiche. Ma attribuzione sempre più rilevante nel bene negli ultimi decenni, quando la crisi di efficienza del sistema giudiziario, ha posto in primo piano il ruolo di “servizio” del dirigente nella assunzione delle scelte organizzative. Questione ulteriormente accentuata per i problemi di gestione delle risorse poste a disposizione del sistema giustizia dal PNRR.
Le criticità dell’organizzazione giudiziaria e l’inadeguatezza del servizio giustizia sono sotto gli oggi di tutti. Peraltro si riconosce che negli anni più recenti vi sono stati notevoli miglioramenti, anche se con forti difformità[5]. “Se l’iniziativa virtuosa di alcuni uffici è dipesa dall’impulso dato dai presidenti di Tribunale e dai procuratori della Repubblica, il più significativo laboratorio di innovazione organizzativa attivo nel settore giustizia in Europa si è trovato in Italia a partire dal 2007, quando l’Unione Europea finanzia con il Fondo Sociale Europeo il programma Diffusione delle best practices negli uffici giudiziari”[6]. Al programma Best Practices hanno partecipato attivamente molti uffici giudiziari grandi e piccoli e il Csm ha svolto un ruolo significativo di propulsione, raccolta di esperienze locali e iniziative di coordinamento.
È diffusa l’opinione che le inefficienze del sistema giustizia, in particolare nel civile, penalizzino e ostacolino lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del Paese: vedi lo studio “Efficienza della giustizia e lotta alla corruzione quali elementi per la competitività del Sistema Paese. Analisi dello status quo e proposte di intervento” curato dal Gruppo di Lavoro The European House – Ambrosetti presentato al Forum del settembre 2020. È significativo peraltro che nel segnalare le criticità il Rapporto dia atto, in più passaggi e con accenti di apprezzamento, delle iniziative poste in essere dal Csm e tuttora in evoluzione.
Il sistema tabellare, precludendo ogni arbitrio del dirigente nella scelta del giudice cui affidare un caso specifico, ha assicurato l’effettivo operare della garanzia del giudice naturale precostituito, ma non ha affatto sminuito il ruolo del dirigente. La predisposizione del progetto tabellare è un momento rilevantissimo nella assunzione di responsabilità sulla organizzazione dell’ufficio, in relazione alla concreta disponibilità delle risorse di personale di magistratura, personale amministrativo, strutture logistiche e tecnologiche. In questa prima fase è essenziale che il dirigente del Tribunale coinvolga i magistrati dell’ufficio, si confronti con il dirigente amministrativo, nonché con il procuratore e l’avvocatura. Il controllo/approvazione da parte del circuito del governo autonomo, Consigli giudiziari e Csm, è momento di garanzia, ma non deve trasformarsi, come talora accade, in occhiuto burocratico esame che può avere il risultato di deprimere l’assunzione di responsabilità da parte del dirigente.
Finalmente con il disegno di legge A.C. 2681 sulla riforma dell’ordinamento giudiziario anche nella procedura di approvazione del Progetto organizzativo delle procure è coinvolto il circuito del governo autonomo. Ma la peculiarità dell’ufficio di procura sottolinea ulteriormente la assunzione di responsabilità del Procuratore. L’ufficio del pm è composto da magistrati indipendenti, ma è organizzato su una struttura in qualche modo gerarchica. Se poi con termini più moderni invece che di gerarchia si parla di governance, di cui il Procuratore è responsabile, il problema rimane. Il singolo pm agisce necessariamente con una forte impronta personale, ma è inserito in una struttura organizzativa.
Il modello rigidamente gerarchico è in crisi in ogni organizzazione complessa, tanto meno può reggere a fronte delle garanzie di indipendenza dei singoli magistrati di una Procura. Rischia di essere sostituito da un modello paternalistico “siamo una famiglia”, che nella pratica vive su una massiccia dose di ipocrisia, ma l’ufficio di procura non si può reggere sull’allegra anarchia o su un modello assembleare.
4. Le “non soluzioni” dei problemi
Le critiche alla gestione da parte del Csm delle nomine agli incarichi direttivi hanno visto la proposta di soluzioni “radicali”.
La più drastica sarebbe il ritorno ad una ingerenza, più o meno accentuata, dell’esecutivo. Nessuno osa proporlo apertamente ma vale la pena di rammentare che questa è stata ed è tuttora in diversi paesi la alternativa alla attribuzione di queste nomine ad organismi del tipo Csm. La torsione autoritaria che ha contraddistinto in Europa paesi come la Polonia e l’Ungheria si è puntualmente tradotta in un ridimensionamento delle attribuzioni degli organismi del tipo Consigli Superiori o Consigli di Giustizia in favore dell’esecutivo. Di fronte a posizioni liquidatorie non è vano riproporre per il Csm quanto disse Winston Churchill nel discorso alla Camera dei Comuni, novembre 1947: “È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora”.
Tra le “non soluzioni” ricorre il mito del criterio dell’anzianità. Declinato in modo rigido esclude ogni discrezionale del Csm e dunque ogni possibile critica ed assicura che non si prenda in alcuna considerazione la questione della organizzazione degli uffici, essendo evidente che l’anzianità di per sé nulla dice sulle capacità organizzative dei candidati. Declinato in modo temperato come “anzianità senza demerito” o “anzianità a parità delle altre condizioni” questo criterio lascia aperti tutti i problemi sull’esercizio del potere discrezione del Csm, non essendovi una unità di misura univoca per il “demerito” o per la situazione di “parità delle altre condizioni”. Ed infatti nei periodi nei quali circolari e prassi sembravano privilegiare in modo netto il criterio dell’anzianità, il Csm, e ancora una volta sia nel bene che nel male, se ne è di volta discostato con tutte le conseguenti polemiche. Una esperienza da non dimenticare è quella del Csm eletto nel 1972; grazie al sistema maggioritario il gruppo di Magistratura Indipendente, con un efficace sistema di alleanze e di concentrazione dei voti, riesce ad assicurare al suo schieramento tutti i seggi con circa il 40% dei voti. Non vi sono studi statistici accurati sulla “politica delle nomine” di quel Csm, ma secondo una valutazione diffusa capitò che, vigendo il criterio dell’anzianità, il residuo margine di discrezionalità nella valutazione del “demerito” e della “parità delle altre condizioni”, abbia determinato che la scelta finale del Csm sia caduta nella maggioranza dei casi su magistrati vicini alle posizioni del gruppo di MI.
Una, più raffinata, ma pur sempre “non soluzione” è stata di recente avanzata da Luigi Ferrajoli.
“È il problema della carriera che va risolto alla radice, eliminando o quanto meno riducendo i presupposti e le ragioni del carrierismo. Dobbiamo infatti riconoscere che la carriera è incompatibile con l’indipendenza interna dei magistrati e perciò della giurisdizione”[7].
Nella linea del contrasto a “carriere e carrierismi”, Ferrajoli avanza diverse radicali indicazioni: “La regola deontologica, per così dire di stile, dovrebbe consistere nel rifiuto della carriera. […] Le riforme, a loro volta, dovrebbero consistere nella soppressione dei presupposti delle carriere”; ma poi, più pragmaticamente, finisce per indicare come rimedi la “effettiva temporaneità degli uffici dirigenti” e per “riabilitare […] il vecchio principio dell’anzianità, ovviamente salvo che il più anziano abbia chiaramente demeritato”. Ed infine, poiché occorre pur misurarsi con il tema della gestione organizzativa degli uffici giudiziari, Ferrajoli conclude: “Si potrebbe poi affiancare, ai capi degli uffici direttori amministrativi competenti all’organizzazione degli uffici, come avviene nelle università e negli ospedali, ovviamente senza alcun potere sulla giurisdizione”. Si arriva così all’ idea di solito nobilitata con l’espressione Court Manager.
Quarta “non soluzione”: l’idea del Court Manager. Ancora da ultimo è stata rilanciata la introduzione negli uffici giudiziari di figure «simili ai court manager, soggetti titolari del caseflow management - cioè, della gestione dei procedimenti e del loro flusso - negli uffici giudiziari statunitensi». Così la proposta del “Comitato programma per l'Italia", presentato su Il Sole 24 Ore il 16 giugno 2021 da Carlo Cottarelli e Alessandro De Nicola.
Sul tema si esprime anche The European House Ambrosetti “Ridisegnare l’Italia. Proposte di Governance per cambiare il Paese - Forum 2021 di Ambrosetti Club 30 marzo 2021” (p. 195) presentato all’ultimo Forum di Cernobbio.
“Introduzione della figura del Court Manager – da selezionare tra manager privati o magistrati che scelgono di dedicarsi esclusivamente ad una carriera gestionale-ammnistrativa – a cui affidare l’amministrazione e l’organizzazione gestionale dell’ufficio giudiziario secondo logiche di coerenza tra obbiettivi e risorse assegnate”.
Il “trapianto” di modelli in contesti diversi per lo più ha dato risultati controproducenti. Ma qui si tocca il nucleo della funzione del magistrato dirigente, giudice o pm. Per i Tribunali la «gestione dei procedimenti e del loro flusso» deve muoversi nel delicato equilibrio tra produttività e celerità da un lato e dall’altro nel rispetto delle garanzie dei giudicabili, prima tra tutte quella del «giudice naturale precostituito» (art.25 Cost.) attraverso il sistema delle «tabelle di composizione degli uffici». “Chi si occupa di cosa?”, nella tradizione, lo decideva il presidente del Tribunale a suo arbitrio; peggio ancora attribuire oggi questo ruolo a un Court Manager. Per la Procura l’attività di indagine è inestricabilmente connessa e condizionante dalle scelte procedurali e gestionali del singolo magistrato nel quadro stabilito dal Procuratore nel Progetto organizzativo.
Piuttosto che pensare a un Court Manager (selezionato da chi?) occorre un forte impegno del Ministero per la formazione e riqualificazione del personale amministrativo, per recuperare il disastro di venti anni di mancato turn over. La Scuola Superiore della magistratura oltre a proseguire nei corsi di gestione degli uffici per gli aspiranti dirigenti deve già nel tirocinio iniziale proporre questa tematica ai neomagistrati.
Quinta “non soluzione” il ritorno al voto segreto in plenum. Le ragioni pro o contro il voto segreto sono note. Vale qui la pena di ricordare che il voto palese fu introdotto con modifica del regolamento interno del Csm alla metà degli anni Ottanta, sulla constatazione che il voto segreto in diverse occasioni, piuttosto che operare a favore della piena libertà del singolo consigliere, si era prestato a logiche di accordi senza alcuna assunzione di responsabilità. Aveva giocato la recente esperienza della controversa nomina del Procurare della Repubblica di Roma, avvenuta con risicata maggioranza: a stare alle dichiarazioni pubbliche rese da numerosi consiglieri quella maggioranza non sarebbe stata raggiunta.
5. Alcune “modeste proposte”
Abbassare la febbre non cura la malattia, ma aiuta. Tre possibili interventi.
Primo. Negli emendamenti recentemente depositati dal Governo al disegno di legge A.C. 2681 sulla riforma dell’ordinamento giudiziario all’art 1, comma 1, la lettera a), dopo la parola “semidirettivi” sono aggiunte le seguenti “di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi”. Se, come pare di comprendere, la revisione operasse nel senso della riduzione la proposta sarebbe pienamente condivisibile. Leggiamo talora in un articolo su rivista accanto al nome del magistrato la qualifica “presidente titolare di sezione…”. Una dizione che ai profani occorre spiegare perché è il risultato del nonsense della esistenza (in particolare in Appello e in Cassazione) di presidenti di sezione che non presiedono nessuna sezione, perché vi sono più presidenti che sezioni. La riduzione dovrebbe operare anche nelle Procure per i procuratori aggiunti, oggi decisamente pletorici.
Secondo. Quanto ai direttivi l’effetto di riduzione sarebbe la conseguenza di una riforma tanto necessaria ed urgente, quanto ignorata: superare i limiti della benemerita quanto incompiuta “riforma Severino”. È la cosiddetta regola del 3: immutate le Corti di Appello, mantenere tutti i Tribunali capoluogo di provincia, almeno tre tribunali per ogni Distretto. Per le Corti di Appello il principio dovrebbe essere quello di una per regione. Ma la Sicilia ne ha quattro: Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania; la Puglia ne ha, di fatto, tre: Bari, Lecce e Taranto. Se due Corti sono sufficienti per macroregioni come Lombardia e Campania altrettante dovrebbero bastarne per Sicilia e Puglia. E’ stato insensato mantenere un Tribunale in ogni capoluogo di provincia, tanto sono diversificate le situazioni. Per la revisione non si partirebbe da zero. Vi è la proposta della Commissione Vietti del 2016 e il ministero della Giustizia dispone di tutti i dati aggiornati necessari. Vi è almeno una ventina di piccoli, troppo piccoli, tribunali in Italia che per loro ridotte dimensioni non sono in grado di garantire efficienza, ed entrano in crisi quando sopravvengono emergenze. L'occasione è unica: fondi europei da utilizzare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Pnrr, concorsi per nuovi magistrati, assunzione di personale amministrativo e ufficio per il processo. Bruxelles vigilerà giustamente su come saranno gestiti i fondi europei. In mancanza di un incisivo e preventivo intervento sulla revisione della geografia giudiziaria sarà inevitabile un rilevante spreco di risorse. Ma il tema è tabu. Anzi le cronache riferiscono di diversi convegni nel centro-sud ove avvocatura e amministrazioni locali invocano la riapertura di mini tribunali soppressi (o “provvisoriamente” mantenuti come in Abruzzo a seguito del sisma). Tra accorpamenti di Tribunali e di Corti di Appello si arriverebbe alla soppressione di una cinquantina di posti direttivi, tra giudicanti e requirenti.
Terzo. Porre dei limiti al “cumulo” di incarichi. Negli emendamenti recentemente depositati dal Governo al disegno di legge A.C. 2681 sulla riforma dell’ordinamento giudiziario il nuovo art. 2 co. 1 lett. i) prevede:
stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di sei anni dall’assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa.
Su altro piano un quarto intervento.
Abbandoniamo la “americanata” del Court Manager e investiamo sul nostro personale amministrativo. Anzitutto nuovi concorsi per colmare i vistosi vuoti di organico provocati dalla dissennata pluriennale politica di blocco del turn over. Cogliere l’occasione per il reclutamento di profili professionali più adeguati alle nuove esigenze richieste dalle innovazioni organizzative nel frattempo intervenute. Infine sperimentare corsi comuni di formazione per dirigenti magistrati e dirigenti amministrativi.
6. La ineludibile discrezionalità del Csm
L’attuazione pratica del sistema di valutazione dei magistrati è oggetto di, non del tutto ingiustificate, critiche. Attualmente sono previsti tre tipi di valutazione: negativo, non positivo e positivo. La Commissione Luciani prevede che il giudizio positivo sia ulteriormente articolato in “discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità di organizzazione del proprio lavoro”.
Si stabilisce una graduatoria più dettagliata, che peraltro non esprime un valore in assoluto, ma si riferisce esclusivamente alle capacità organizzative. E’ vero che le valutazioni “negative” e “non positive” costituiscono una percentuale ridottissima. A dispetto dei toni polemici con i quali spesso sono citati questi dati, si deve ricordare che è del tutto fisiologico che i casi di magistrati da “espellere” siano limitati, come risulta anche dalle statistiche di altri paesi europei. Semmai si dovrebbe ammettere una maggiore possibilità di ricorrere alla valutazione “non positiva”, la quale, senza l’attuale automatismo della decadenza dall’ordine giudiziario in caso di reiterazione, potrebbe valere come robusto stimolo a correggere insufficienze.
L’idea sottesa alle posizioni liquidatorie dell’attuale sistema di valutazioni sembra essere quella di stabilire tra i magistrati una graduatoria di merito assoluto. Una tale graduatoria è impraticabile, tanto diverse sono le funzioni e le specializzazioni in magistratura; si dimentica poi che l’obbiettivo da perseguire non può essere quello di selezionare un gruppetto di magistrati eccellenti, da assegnare magari agli uffici più importanti, ma quello di assicurare comunque un livello medio diffuso di adeguata professionalità, sempre in aggiornamento. L’obbiettivo condivisibile dell’emendamento proposto è quello di arricchire gli elementi di valutazione presenti nel fascicolo personale per l’eventuale futuro conferimento di funzioni direttive o semidirettive.
Se compito difficile è quello della valutazione della professionale di tutti i magistrati, ben più arduo quello di individuare “l’uomo giusto al posto giusto”, si diceva ieri e oggi “la persona giusta al posto giusto” per un incarico direttivo. Per quanto, meritoriamente, si indichino le qualità richieste: capacità organizzativa, preparazione giuridica, esperienza, capacità di interrelazione etc, rimane il fatto che non vi sono unità di misura per valutare ciascuna di queste qualità e la sintesi complessiva e men che meno per rapportarle alla specificità del singolo incarico direttivo da coprire.
Sono ovvietà, ma normalmente eluse, perché costringono a misurarsi con l’ineluttabile rilevante tasso di discrezionalità nella scelta del dirigente di un ufficio giudiziario, a chiunque questa scelta sia alla fine attribuita: esecutivo, Csm o giudice amministrativo.
Tralasciando qui i due termini estremi, fissiamo l’attenzione su un organismo come il Csm a composizione mista di laici e togati.
Tralasciamo le patologie degli accordi di scambio che investono una pluralità di posti, logica che può essere contrastata solo da un impegno etico, dal recupero di credibilità della giustizia, il “voltare pagina” richiesto dal Presidente Mattarella già il 21 giugno 2019, valorizzando tutte le potenzialità del modello voluto dalla Costituzione.
Tralasciamo ancora il caso, non infrequente peraltro, in cui per quel posto vi sia una candidatura che spicca nettamente sulle altre e che raccoglie la unanimità dei consensi.
Nella maggioranza dei casi, o comunque molto frequentemente, vi possono essere due, tre quattro persone “abbastanza giuste” per quel posto. Il Csm è composto da donne e uomini, togati e laici, che è da supporre abbiano delle loro idee sui temi di giustizia in generale e sulla organizzazione giudiziaria. La prassi costante ha condotto il Parlamento, nella nomina dei laici, ad assicurare il pluralismo delle posizioni politico/culturali. Qualunque sia il sistema elettorale dei togati anche i consiglieri hanno posizioni politico culturali sui temi di giustizia.
L’idea che vi siano unità di misura incontrovertibili per pesare le qualità che condurranno alla ineluttabile indicazione per uno ed un solo candidato a quel posto è all’evidenza fuori della realtà. La linea di individuare parametri, indicatori etc è animata da buone intenzioni, ma quando viene spinta troppo oltre (come si è verificato) dimostra la permanente validità del detto sul modo migliore per lastricare la via per l’inferno.
Le donne e gli uomini, laici e togati, che compongono il Csm “a parità di condizioni” (con tutti i limiti che abbiamo indicato per questo riferimento) del tutto legittimamente si orienteranno nel voto per “la persona giusta al posto giusto” sulla base di valutazioni discrezionali. Meglio per quel posto privilegiare le capacità organizzative o la competenza giuridica, meglio per quel posto di procuratore un candidato esperto particolarmente in criminalità organizzata piuttosto che in reati societari? E infine, sempre “a parità di condizioni”, non potrò legittimamente preferire quel candidato che è più vicino alle mie idee sul ruolo del giudice e della giurisdizione? Ed ancora, sempre “a parità di condizioni” potrò legittimamente preferire un candidato vicino alle mie idee tradizionaliste in materia di giustizia ovvero, per essere “imparziale”, dovrei votare per il candidato piuttosto innovatore e progressista, il più lontano dalle mie idee?
Problemi aperti, questioni delicate. Il peggio è far finta che non esistano.
Ed ancora. La procedura per la nomina dei direttivi è articolata tra la fase iniziale della proposta della Commissione Direttivi e il voto finale del plenum. Dobbiamo immaginare che la maggioranza dei consiglieri, quelli che non fanno parte della Commissione, ma il cui voto sarà decisivo in plenum, arrivino alla delibera finale del tutto vergini e lì per la prima volta apprendano del dibattito che si è svolto in commissione e delle motivazioni che sorreggono eventuali alternative proposte? Si deve nominare il Presidente della Cassazione, il Procuratore della Repubblica di Palermo, il Presidente del Tribunale di Milano o anche il Presidente del Tribunale della piccola città nella quale io togato ho prestato servizio o io laico esercito come avvocato o insegno alla locale Università ed io togato o laico, che non faccio parte della Commissione, per essere “imparziale” mi disinteresso totalmente della questione prima del plenum. Nel mentre magari la stampa dà ampiamento conto del profilo dei candidati. Tutto ciò non solo è fuori della realtà, ma è irragionevole. Deprechiamo giustamente accordi sotterranei e logiche deteriori di scambio. Il Csm è un organo collegiale che non ha e non deve avere una maggioranza stabile precostituita. La maggioranza pur necessaria per la decisione finale in plenum non può che formarsi attraverso la convergenza di posizioni diverse e, auspicabilmente, dopo un previo confronto e scambio di opinioni e di valutazioni, che abbia consentito una presa di posizione più consapevole sulle proposte della Commissione.
7. Ultimo
Smettiamola di piangerci addosso. L’Hotel Champagne esiste e pesa come un macigno da superare, ma il mondo non inizia e non finisce lì. Il Csm nei sessant’anni di vita non sempre ha operato le scelte più adeguate nella nomina dei dirigenti. Ma chi ha vissuto in magistratura l’ultimo mezzo secolo può testimoniare, senza tema di smentite, che il livello medio della dirigenza è cresciuto in una progressione costante e significativa. Molto resta da fare, ma, nonostante tutto, moltissimo è stato fatto.
[1] F. Cordero, I poteri del magistrato, in “L'indice penale”, n. 1, 1986, p.31.
[2] Sulla vicenda della riforma della “carriera” vedi E. Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Laterza, Bari-Roma 2918 p. 79 sgg.
[3] G. Foschini, Giudici in nome del popolo, non già commissari del capo della corte, in “Foro Italiano”, 1963, II, c.168 sgg. Sul tema R. Romboli, Il giudice naturale, Giuffrè, Milano 1981.
[4] S. Senese, La prassi applicativa del Csm, in Il principio di precostituzione del giudice, Quaderni del Csm cit.p.240.
[5] Si veda in particolare D. Piana, Uguale per tutti? Giustizia e cittadini in Italia, Il Mulino, Bologna 2016
[6] D. Piana, Uguale per tutti? cit. , p. 94-95
[7] L. Ferrajoli, Magistratura e democrazia, in Questione giustizia 28 luglio 2021

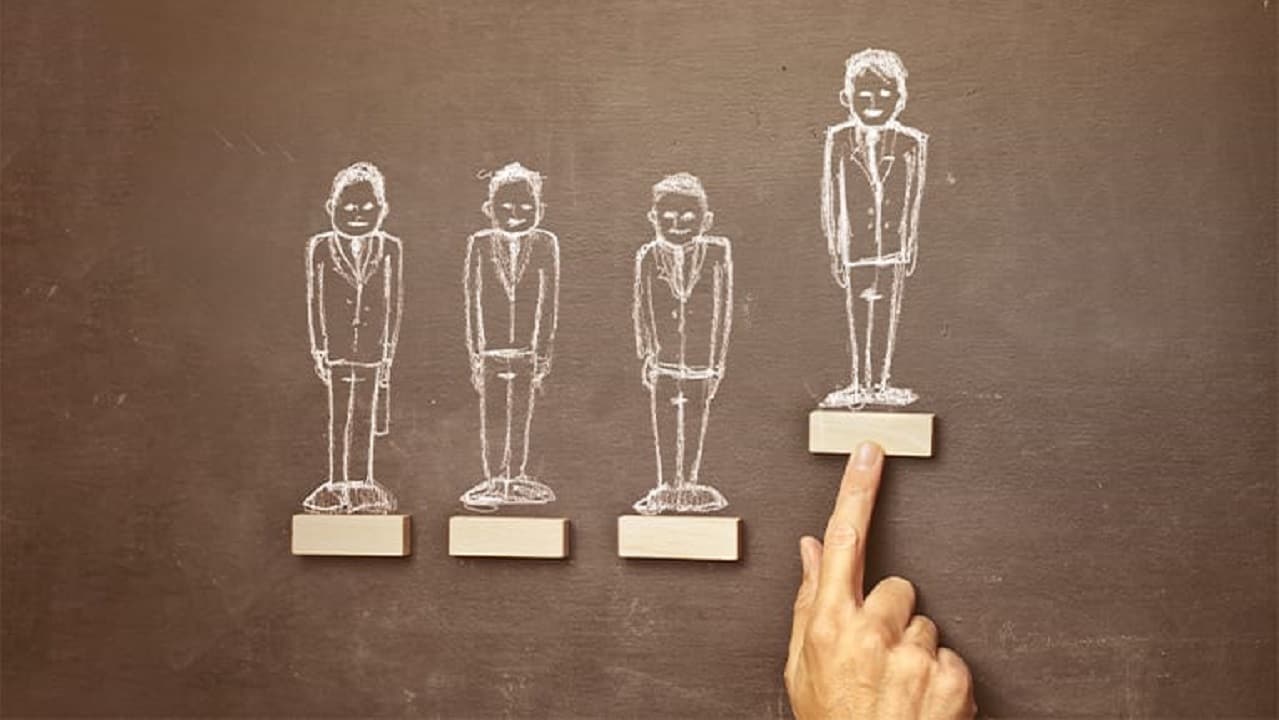

 And then Add to Home Screen.
And then Add to Home Screen.